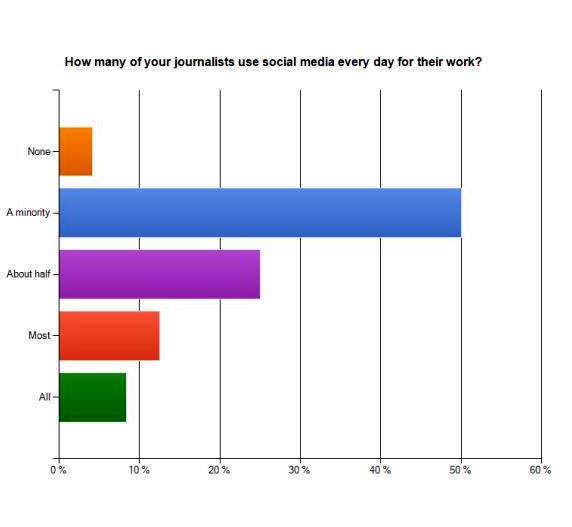Message, Nr. 2, aprile 2005
di Giovanni Zavaritt
«To whom are you true?» è la domanda provocatoria con la quale si apre il volume edito da Stuard Allan and Barbie Zelizer, dedicato al giornalismo in tempo di guerra. È una domanda radicale, che esprime bene sia la problematicità professionale interna al sistema dei media, sia la dimensione etica che il riportare fatti di guerra comporta.
Come gli autori sottolineano, l’intento del libro è proprio quello di identificare e criticare l’insieme delle pressioni che tengono sotto scacco il giornalismo di guerra del ventunesimo secolo. Allan e Zelizer, alla luce dei diversi interventi, ne forniscono una lista dettagliata. Si parte dagli imperativi aziendali, che impongono ai canali d’informazione nuovi atteggiamenti capaci di fare il pieno di ascolti, spingendo verso una cronaca partigiana dichiaratamente schierata, come accade nel caso della Fox News. Si arriva al grande capitolo della propaganda ed alle sue sfaccettate, forti e fini attività di persuasione. Nell’ordine: uso strategico dell’accesso alle fonti; cura degli aspetti linguistici e sfruttamento del potere evocativo delle immagini; stipulazione di veri e propri contratti per avere giornalisti embedded in prima linea, tra le proprie fila.
Schiacciato in questa frizione continua, al giornalista di guerra resta sempre meno spazio per fare il suo mestiere; ad un livello superiore, direttori di radio, TV e giornali restano vittime della stessa dinamica, ponendo in agenda solo un certo tipo di conflitti, presentandoli solo in un determinato modo. Il pessimismo sulla possibilità di avere un giornalismo di guerra di qualità, in cui prevalgano la ricerca di più fonti, lo sforzo di contestualizzare, l’essere veloci ma precisi ed indipendenti, si articola lungo tutto il volume, in particolare grazie ad alcuni interventi: Oliver Boyd Barret insiste sulle capacità di disinformazione nelle mani del Pentagono, che superano di gran lunga il già pessimistico “propaganda model” proposto da Herman e Chomsky nel 1988. Piers Robinson ridimensiona il mito secondo il quale il progresso tecnologico porterebbe ad una maggiore indipendenza dei giornalisti: il coltello è ancora abbondantemente nelle mani degli ufficiali militari ed i media supportano in sostanza i loro obiettivi. Philp Hammond prendendo spunto dal conflitto balcanico, sostiene la tesi secondo la quale gli sforzi comunicativi delle forze inglesi ed americane siano incentrati sulla costruzione di una nuova retorica di guerra, che sostituisca il «nemico comunista» con il terrorismo internazionale, la lotta liberale con lo spirito dell’intervento umanitario. Sempre restando in tema di retorica, Howard Tumber descrive come avere dei giornalisti embedded paghi dal punto di vista linguistico: in modo ragionato od inconscio i pezzi scritti in prima linea tendono tutti ad identificare un ‘noi’ ed un ‘loro’, alimentando l’identificazione con le truppe e la simpatia per la strategia militare.
Internazionale, scientifico e professionale, il libro di Stuard Allan and Barbie Zelizer getta una luce cupa sul panorama contemporaneo del giornalismo di guerra: uno sguardo pessimista, che purtroppo si potrebbe definire semplicemente realistico.
***
Reporting War, journalism in war time – edito da Stuard Allan e Barbie Zelizer – Routledge 2004.