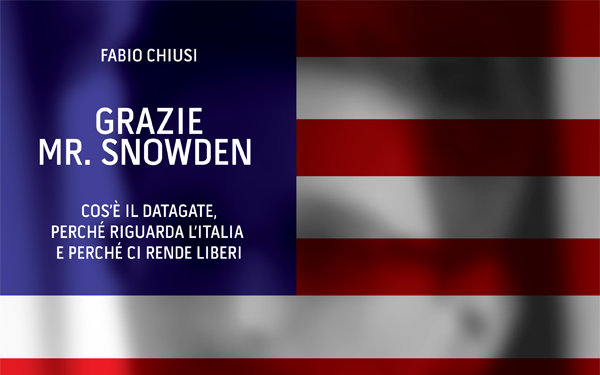L’ultimo Community Standards Enforcement Report di Facebook pubblicato a novembre 2020, pone l’accento sugli hate speech, in riferimento al periodo luglio – settembre 2020. I numeri, in confronto al medesimo periodo preso in considerazione nel 2019, sono degni di nota: 22.5 milioni di contenuti, violanti le norme comunitarie della piattaforma, su cui Facebook è dovuto intervenire mentre lo scorso anno il conteggio si fermava a 6.9 milioni. Il Report non riporta le cause di tale incremento, ma la pandemia in corso è probabilmente una delle principali cause.
Passando a Instragram la situazione, seppur con conteggi inferiori, non cambia: il confronto luglio – settembre 2020, per indisponibilità di dati forniti da Facebook, avviene con ottobre – dicembre 2019, il quarto trimestre dove si contavano oltre 645mila contenuti d’odio su cui si è dovuti intervenire contro i 6 milioni e mezzo del periodo esaminato nel 2020. Come detto, le cause o le tipologie di contenuti da cui scaturiscono gli hate speech non emergono dal Report ma è doveroso tenere conto che i social network sono sempre più il volano principale per la diffusione di notizie attraverso le pagine ufficiali dei mass media e non solo.
Un emblematico paper, pubblicato dal Berkman Klein Center for Internet and Society di Harvard, evidenzia il ruolo dei social network in relazione alla disinformazione: “le campagne di disinformazione efficaci sono spesso un processo guidato dai mass media e guidato dall’élite in cui i social media hanno svolto solo un ruolo secondario e di supporto”. Interessante in merito è l’articolo pubblicato dal Washington Post” dal titolo “How Digital Disinformation Sows Hate, Hurts Democracy: QuickTake”, ovvero la disinformazione semina odio e fa male alla democrazia.
Le falsità, le notizie non verificate o quelle distorte così come il fenomeno del clickbaiting in certi casi, soprattutto se perpetrati sui social network, modificano la percezione dell’audience rispetto a un determinato argomento “seminando”, appunto, odio. Disinformazione, social ed hate speech diventano, nei momenti di deriva, tre volti della stessa medaglia. A questo proposito lo studio “Hate speech and hate crime in the EU and the evaluation of online content regulation approaches”, pubblicato nel luglio del 2020 e commissionato dall’European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs su richiesta del LIBE Committee esamina i tre fenomeni nel sottocapitolo “Populism and Hate Speech”.
Si legge nel testo (traduzione in italiano a cura dell’autore, ndr): “i leader populisti sfruttano il loro accesso diretto all’elettorato attraverso i social media. Senza il filtraggio e la critica della stampa indipendente, possono sviluppare liberamente narrazioni alternative della realtà. Se i leader degli stati si dedicano all’incitamento all’odio, la loro autorità e la loro percezione di affidabilità rendono l’incitamento all’odio più accettabile. Messaggi autorevoli ripetuti frequentemente hanno il potenziale di abbattere le barriere morali e di dare un biglietto gratuito alla violenza”.
Nonostante in questo caso ci si riferisca ai discorsi politici, l’esempio è calzante per cercare una correlazione con i mass media che, di fronte alla diffusione degli hate speech, fungono da attore di mezzo, eticamente parlando, nello scenario prefigurato. I mass media e i giornalisti percepiscono la differenza rispetto ad un fatto dove altri non arrivano, citizen journalism a parte, e (sperando sempre) nel rispetto della deontologia professionale lo ripropongono. Il rischio di generare discorsi d’incitamento all’odio è elevato, anche quando il processo mediatico di diffusione della notizia è “oggettivamente” corretto.
Basti pensare agli hate speech che possono nascere quando una testata autorevole pubblica, sotto forma di articolo o servizio, un’affermazione di un politico che si “pubblicizza” da solo attraverso i social network, a prescindere dal fatto che quanto affermi sia veritiero. Affermazioni politiche discutibili, spesso, danno vita a una “notizia”, intesa con le relative valutazioni del caso di volta in volta ed in coerenza col diritto di cronaca, che viene riproposta dal medium o dal giornalista di turno sulla propria pagina ufficiale. A questo punto, il giornale che ha riproposto una notizia polemica volta a spaccare l’audience, diventa “complice” della diffusione di hate speech o svolge semplicemente il suo “dovere”?
Una risposta definitiva, “giusta” e che possa soddisfare tutte le parti coinvolte in questo processo non c’è, soprattutto perché spesso la valutazione è appannaggio del contesto. Dei consigli o linee guida su come operare con i dovuti accorgimenti di fronte agli hate speech per i giornalisti arrivano però da un articolo promosso dal Center for Journalism Ethics della School of Journalism and Mass Communication dell’University of Wisconsin – Madison. Nell’articolo di approfondimento, intitolato “A guide to covering hate speech without amplifying it”, la premessa parla chiaro: “I giornalisti devono coprire i discorsi di odio in modo che siano poi esposti al controllo pubblico. La società può poi decidere che i punti di vista d’odio non siano socialmente accettabili” (traduzione a cura dell’autore, ndr).
I suggerimenti che seguono, seppur basati sulla giurisprudenza americana, sono in primis diretti alla considerazione dell’importanza e del potere della cornice entro cui vengono considerati, ovvero “power framework”: sta al giornalista comprendere quando sia “legittimo” divulgare qualcosa in relazione agli hate speech o meno, rispetto alla legge ed al campo di competenza del giornalismo. Un aItro punto, è legato alla cosiddetta “newsworthiness”, la dignità della notizia. Dal Center for Journalism Ethics la massima in merito è “il discorso d’odio e oltraggioso può essere protetto dalla Costituzione, ma solo perché il discorso è protetto non vuol dire che faccia notizia” (trduzione a cura dell’autore, ndr).
Il terzo punto è riassumibile nell’osservazione del contesto e, in proposito, secondo Caitlin Ring Carlson, Professoressa associata di comunicazione all’Università di Seattle, non contestualizzando l’incitamento all’odio, il giornalista non racconta l’intera storia e, a sua volta, rende un disservizio al pubblico. Quando un giornalista non riesce a spiegare il contesto del discorso, il pubblico potrebbe non comprenderne la gravità e i suoi effetti negativi sulle comunità emarginate (verso cui l’hate speech potrebbe essere scagliato). L’ennesimo punto da prendere in considerazione è “la correttezza e l’inquadratura” rispetto alle modalità di diffusione di un hate speech mettendo al centro il tema della neutralità che, seppur debba essere sempre il “must” del giornalista, in taluni casi secondo Whitney Phillips, Assistant Professor di comunicazione e studi retorici all’Università di Syracuse di New York, non rappresenta realmente l’essere imparziali.
Per Whitney i giornalisti dovrebbero enfatizzare le prospettive di coloro che sono stati danneggiati dall’incitamento all’odio invece di offrire all’aggressore un’opportunità per giustificare le loro opinioni ripugnanti. I giornalisti, inoltre, dovrebbero anche evitare di inquadrare i cattivi attori come il centro della narrazione, poiché questo comportamento amplifica l’incitamento all’odio anche quando ha lo scopo di condannarlo. Infine, nell’articolo, ritorna il contributo di Carlson che rispetto alla gestione degli hate speech per i giornalisti suggerisce il “ritorno alle basi”, alla ricerca della verità con la ferma convinzione che un “hate speech isn’t free speech”. E per questo va (correttamente) biasimato.