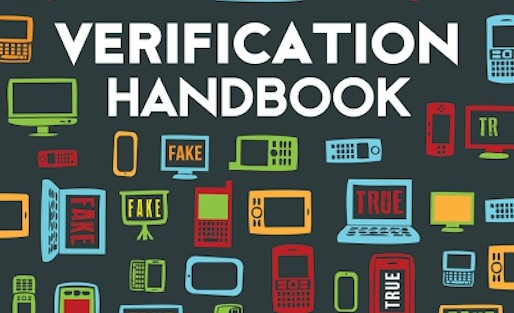Articolo di Stephan Russ-Mohl e Andrea Hoehne
Corriere del Ticino, 21.5.2004
A proposito di chi approfitta dei conflitti, dei reporter famosi e di «aria fritta»
Le vivaci diatribe sulle torture perpetrate ai danni di detenuti iracheni in Iraq o sui terribili video di barbare esecuzioni di ostaggi occidentali non sono che l’aspetto più visibile di un conflitto che non si combatte solo a suon di bombe e proiettili. Le guerre moderne si realizzano infatti su due fronti: sul campo di battaglia e su quello dei media. Al recente convegno annuale della Netzwerk Medienethik a Monaco si è esaminato il ruolo dei media e del giornalismo nella guerra in Iraq. Gli studiosi Andrea Höhne e Stephan Russ-Mohl si sono concentrati sugli aspetti economici della corrispondenza di guerra. Ecco i risultati delle loro ricerche.
Alcuni brillanti osservatori dei media durante la terza guerra del Golfo hanno seguito le corrispondenze sia da questa parte che dall’altra dell’Atlantico – tra di loro l’editore Hubert Burda – e hanno avuto l’impressione che i media trattassero due guerre completamente diverse. In Germania si è dubitato sin dall’inizio delle due principali motivazioni alla guerra fornite dal governo Bush. Al contrario i media americani hanno creduto al presidente quando ha affermato che Saddam Hussein stava minacciando il mondo con armi di distruzione di massa e che intratteneva rapporti con l’organizzazione terroristica Al-Qaida.
Le due più importanti riviste specializzate per giornalisti degli Stati Uniti, l’American Journalism Review e la Columbia Journalism Review, sono giunte in retrospettiva allo stesso giudizio distruttivo: i media americani, in particolare le reti televisive, avrebbero trattato il governo Bush con i guanti di velluto sul tema dell’Iraq. Dopo l’ 11 settembre gli Stati Uniti sono stati travolti da un’ondata di patriottismo. Già ai preludi della guerra questo clima ha intimidito le voci critiche, fino a farle tacere. Questo perché nessun media poteva permettersi di andare contro il proprio pubblico e dunque mettere a repentaglio i conti della società. Un comportamento estremamente favorevole al governo è stato sostenuto dai media di Rupert Murdoch. Oltre alla propria rete informativa Fox, in tutto il mondo 175 testate appartenenti al suo impero si sono espresse in favore di Bush e Blair. Questo è ciò che ha scoperto il Guardian.
Servizi asettici
Secondo molti analisti l’unilateralità della corrispondenza di guerra è stata favorita dall’ «embedding» (l’incorporazione) dei giornalisti nelle truppe e il controllo che ne è derivato. I militari hanno forzato l’embedding. Molti servizi degli «embedded journalists» sono risultati stranamente «asettici». La situazione reale è rimasta spesso nell’ombra: per esempio – secondo le imposizioni di censura militare – non sono mostrate immagini di soldati americani e inglesi feriti, e nemmeno di civili iracheni vittime della guerra. A questo punto è possibile una prima conclusione: a quanto pare in tempo di guerra la capacità di rendimento dei giornalisti si riduce, nonostante un imponente dispiegamento di mezzi e risorse. È piuttosto improbabile che il pubblico venga informato oggettivamente o anche solo «realisticamente», o che venga a sapere dai media fatti e retroscena rilevanti.
Perché? Le parti in guerra armano le proprie pubbliche relazioni e i mezzi di propaganda in maniera sempre più efficace, mentre i giornali non sono in grado di aumentare le proprie capacità nella stessa misura. Inoltre l’influenza e la pressione dei militari sui giornalisti di guerra, ma anche la messa in scena di eventi bellici che si prestano in modo particolare a diventare notizie, sono cresciuti in maniera massiccia.
Più ascolti, meno pubblicità
La critica dei media di «sinistra» mette volentieri alla gogna gli impresari mediali come coloro che aumentano i profitti grazie la guerra. Si va da William Randolph Hearst, che svolse un ruolo poco onorevole nella guerra tra Spagna e America alla fine del diciannovesimo secolo, fino ad arrivare a Silvio Berlusconi e Rupert Murdoch.
Ma quanto è attendibile questa tesi? Di certo le guerre aumentano le vendite e gli ascolti. D’altra parte durante i periodi di guerra le imprese mediali perdono entrate pubblicitarie che, per i loro bilanci, sono molto più importanti. Le edizioni speciali si sostituiscono agli spazi pubblicitari, anche perché in molti settori non ha senso fare pubblicità durante i periodi di guerra. Inoltre la corrispondenza di guerra è costosa e gli alti costi di produzione devono essere coperti. Dati che descrivano l’andamento dei guadagni e delle perdite dei media durante la guerra, secondo le nostre conoscenze, non ne esistono. Si può però supporre che i media orientati al guadagno, parleranno della guerra in maniera tale da far quadrare i conti. Questo spiega anche perché ci sono guerre, come per esempio in Africa, di cui non veniamo praticamente a conoscenza.
Rispetto alle fazioni in guerra e agli editori, i giornalisti sono più raramente nel mirino della critica mediale. Ma anche loro contribuiscono a far sì che la corrispondenza sia quella che è. I giornalisti non sono soltanto vittime degli «spin doctors» (i consulenti politici che vogliono manipolare i media e quindi l’opinione pubblica) e del sistema dei media costretto a risparmiare. Essi sono attori con interessi propri, per quanto differenti tali interessi possano essere. La maggior parte dei corrispondenti di guerra partecipa in qualche modo al gioco delle parti in guerra: non per ignoranza o stupidità, ma perché per loro è più «vantaggioso» . Contemporaneamente, a seconda del carattere personale, domina in alcuni casi la voglia di avventura o di voler fare carriera, e in altri l’interesse a mantenere il proprio posto di lavoro.
La voce del padrone
Perché i giornalisti dell’impero di Murdoch hanno sostenuto anche in paesi dove la maggior parte della popolazione era contraria alla guerra – come Australia, Nuova Zelanda e Inghilterra – che Bush e Blair erano sulla strada giusta, andando contro la maggioranza del pubblico? In questo caso la risposta economica è che i giornalisti si sono adeguati alle direttive del proprietario dei media, che non ha tralasciato nessuna possibilità per esprimersi pubblicamente a favore della guerra. Quindi i suoi giornalisti hanno dato più peso al potere di sanzione di Murdoch, che non ai «costi personali» derivati dal mettersi contro il pubblico. È comunque sorprendente come Murdoch sia riuscito a sincronizzare il suo impero senza lasciare traccia, tramite direttive di censura non troppo esplicite. La spiegazione più plausibile è che in tempi di guerra l’autocensura dei giornalisti funzioni particolarmente bene, in ultima analisi per paura di perdere il posto di lavoro.
Le notizie non si scelgono in base all’interesse pubblico
Perché i corrispondenti diffondono, con routine e ventiquattro ore su ventiquattro, aria fritta davanti alle telecamere anche quando non c’è nulla da raccontare? Ovviamente perché il loro impiego costa ai loro datori di lavoro molti soldi e quindi, anche solo per questo motivo, una volta arrivati sul luogo devono produrre qualcosa. Ma sicuramente anche per interesse personale, per potersi vantare della propria importanza. Spesso stanno seduti a migliaia di chilometri di distanza dagli avvenimenti. Di conseguenza non possono sapere più di quanto possano scoprire le redazioni attraverso le agenzie di stampa. Nonostante ciò i media danno l’impressione che i corrispondenti diano informazioni dal vivo. Ciò può anche far bene all’ego del giornalista e agli indici di ascolto, ma non ha nulla a che vedere con un’informazione seria.
Anche l’ «embedding» dei giornalisti di guerra nelle truppe USA, è spiegabile economicamente. E cioè come un rapporto di scambio. I militari offrono l’accesso alle informazioni e danno protezione ai giornalisti. In cambio dal giornalista ci si aspetta che contraccambi con il mantenimento dell’interesse pubblico, e questo in maniera possibilmente accondiscendente. Fatto che diventa ancora più probabile dal momento che giornalisti e militari condividono la quotidianità e le difficoltà della guerra. Durante la guerra in Iraq, già solo per una questione di sicurezza la maggior parte dei giornalisti ha lavorato da «embedded». In questo modo si è ottenuto un doppio risparmio: si è ridotto il dispendio per la ricerca e i pericoli per i giornalisti.
Anche durante la guerra le informazioni sono una merce che facilmente va a male; la rarità più preziosa è ovviamente l’esclusiva. I giornalisti vivono sempre meno di produzione della notizia, e più sulla confezione, sulla scelta della notizia e sul suo scambio. Scegliendo tra un eccesso di informazioni offerte dalle agenzie stampa e dalle agenzie di pubbliche relazioni, trasformano le informazioni in notizie e scambiano quindi informazioni con interesse. Si tratta quindi di transazioni di mercato, che si possono analizzare economicamente. La scelta della notizia non è effettuata in base a un «interesse pubblico», difficilmente definibile, ma avviene in base alla sua priorità economica. Ciò che promette alti indici di ascolto arriva in prima serata e spesso viene anche inscenato con i tempi giusti dalle agenzie di pubbliche relazioni. I valori stessi delle notizie sono cambiati: nella scelta delle notizie i giornalisti seguono, spesso inconsciamente, imperativi economici.
Fanno parte del comportamento razionale dei giornalisti – in caso di guerra, come nella quotidianità – la rinuncia alla ricerca quando le fonti, come ad esempio le agenzie stampa o altri media, appaiono credibili; fenomeno che riguarda anche la stampa specializzata in giornalismo, fino ad arrivare al plagio. In questa maniera si possono spiegare gli errori collettivi: i giornalisti sono facilmente vittime, come ognuno di noi, del «groupthink» , cioè del «pensiero di gruppo» che si forma quando un gruppo di persone si ritrova nella stessa situazione e tende a condividere una medesima interpretazione dei fatti. E naturalmente i telecronisti diventano celebrità se effettuano per alcune settimane la corrispondenza dalle zone in guerra. Possono commercializzare con profitto le proprie esperienze in libri, conferenze e altro. Promettono storie avvincenti anche perché i corrispondenti di guerra tendono ad auto- eroicizzarsi. Nelle loro corrispondenze i pericoli a cui sono sottoposti sono enfatizzati più del dovuto. E, scabroso ma vero, i giornalisti dedicano anche più attenzione ai loro colleghi uccisi in guerra che non, per esempio, a infermieri o medici uccisi.
Tre filtri dal fronte a casa nostra
Ma arriviamo finalmente alla parte positiva. Ovviamente esistono anche esempi contrari. Sono rari, e alla luce dell’informazione spazzatura dalla quale veniamo bombardati, è abbastanza improbabile che tali corrispondenze arrivino all’opinione pubblica.
Comunque 20 sui 500 giornalisti embedded nelle truppe inglesi e americane, nella guerra in Iraq, hanno rischiato e si sono mossi da soli. Azione che però comporta alti costi: il pericolo per la propria vita non veniva soltanto da parte degli iracheni, ma anche dei militari americani.
Si può spiegare in maniera economica anche il comportamento di tali giornalisti – «Eroi»? Forse non tutti possono capirlo, ma questi giornalisti stimano i vantaggi dell’indipendenza – la speranza in uno scoop, il guadagno di prestigio e la carriera lavorativa – più dei rischi (lavoro di ricerca, pericolo di vita). O cercano l’adrenalina nell’avventura e nel rischio.
Riassumendo giungiamo a questo «modello» della corrispondenza di guerra: prima di arrivare ai destinatari gli avvenimenti bellici vengono filtrati più volte. Il primo filtro è costituito dalle stesse parti in guerra, che cercano di strumentalizzare i media per i propri scopi. Il secondo filtro è formato dagli interessi economici degli editori: le notizie vengono elaborate in maniera da generare un aumento degli indici di ascolto e delle edizioni. Fungono da terzo filtro i corrispondenti di guerra: fa parte della loro strategia di sopravvivenza valutare i rischi, quindi calcolare i «costi» e i «benefici» delle loro azioni, scambiando informazioni e protezione durante la ricerca delle notizie.
Proposte su come si possa migliorare la qualità della corrispondenza diventerebbero dunque più realistiche se non si accusassero soltanto le parti in guerra – quindi politici e militari – di avere un atteggiamento egoista ed economico, ma anche le case editrici e i giornalisti.
Traduzione: Mirjam Schmid