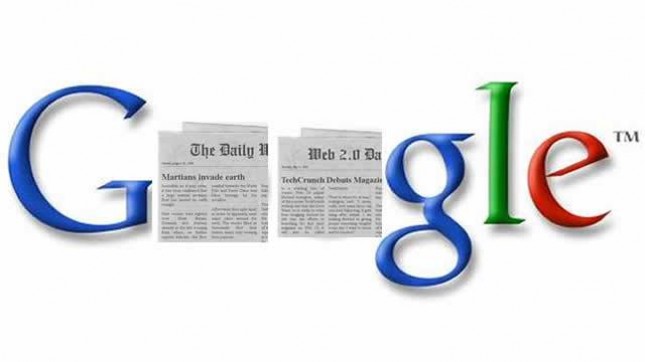Corriere del Ticino, 14.1.2005
di Cristina Elia, Marcello Foa e Stephan Russ-Mohl
Due illustri giornalisti americani rischiano 18 mesi di prigione perché non vogliono rivelare il nome dei loro informatori. I mass media tra giustizia e controlli.
Non molto tempo fa poter vantare una permanenza in prigione, o almeno alcuni giorni di detenzione preventiva, era quasi necessario per una biografia giornalistica di rilievo. Non perché i giornalisti rubassero argenteria o fossero sospettati di aver commesso rapine in banca, ma perché nello svolgimento del lavoro erano preventivati conflitti con il potere statale. Conflitti che ci sono ancora oggi ogni qual volta i giornalisti non si limitano a divulgare i messaggi PR delle amministrazioni, ma vanno oltre cercando notizie che vengono tenute nascoste all’opinione pubblica. Gli americani, dai tempi di Teddy Roosevelt, chiamano questo «muckraking» – ossia «sollevare un polverone».
Dovrebbe quindi interessare tutti se attualmente due giornalisti, Judith Miller del New York Times e Matthew Cooper della rivista Time, rischiano 18 mesi di prigione? E non perché abbiano infranto la legge, ma solo come conseguenza del fatto che si sono rifiutati di rendere noto il nome dei propri informatori in un caso che interessava l’autorità giudiziaria. Un caso grave: la libertà di stampa è minacciata nella sua sostanza. E non in uno dei problematici stati dell’ex Unione Sovietica o in Cina o in Africa, dove da sempre i giornalisti non hanno vita facile, ma nella democrazia più potente del mondo: gli Stati Uniti d’America.
Mettere in dubbio il diritto dei giornalisti di proteggere le proprie fonti tocca la sostanza del Primo Emendamento, che negli Stati Uniti sancisce la libertà di parola, di espressione e di stampa – e che in Svizzera corrisponde all’articolo 17 della Costituzione Federale.
Occorre fare una riflessione su quali possano essere le conseguenze di una sentenza contraria ai giornalisti, come anche sul perché per i giornalisti sia importante la garanzia del segreto redazionale.
Se i tribunali statunitensi dovessero mandare Miller e Cooper in prigione, questo toccherebbe il nocciolo delle attività giornalistiche che, nell’interesse dell’opinione pubblica e della democrazia, sono necessarie e devono rimanere possibili. Una sentenza del genere metterebbe in dubbio l’indipendenza della stampa dal governo e costituirebbe un deterrente per i giornalisti dal trattare questioni spinose – impedendo lo svolgersi del giornalismo investigativo.
Inoltre se i giornalisti rivelassero le proprie fonti, in futuro nessuno si confiderebbe più con i media aiutando a portare alla luce gli scandali. Di fatto senza questi informatori chiacchieroni i giornalisti riescono di rado a illuminare i lati oscuri e impenetrabili degli affari politici e della vita economica. Molti giornalisti considerano perciò sacra la promessa fatta alle proprie fonti di restare confidenziali e nella storia del giornalismo essi hanno ripetutamente affrontato la prigione per proteggere i propri informatori.
Quello di Miller e Cooper non è un caso isolato: negli ultimi sei mesi i giudici statunitensi hanno minacciato di sanzioni o di prigione almeno otto giornalisti per lo stesso motivo, ossia per non aver voluto menzionare i propri informatori.
L’altra faccia della medaglia è evidente: i giornalisti godono grazie alla libertà di stampa di privilegi unici dei quali non devono approfittare come è successo più volte in passato. È quindi importante e desiderabile che da entrambi i lati – il giornalismo da una parte e l’autorità giudiziaria dall’altra – ci sia una maggiore capacità di immedesimazione e di consapevolezza delle conseguenze.
Infatti dove l’autorità giudiziaria non riesce ad imporsi quale garante della libertà di stampa e di opinione, questa libertà, alla lunga, finirà in cattive acque. Se d’altra parte i giornalisti non sviluppano una sensibilità per il fatto che anche la protezione degli informatori può avere dei limiti e che è da soppesare con altre leggi, c’è il rischio che i giornalisti perdano, abusandone, i propri preziosi privilegi.
Il diritto alla protezione delle fonti è un presupposto centrale perché i giornalisti possano esercitare il proprio importante ruolo nel delicato equilibrio di limitazione dei poteri che si viene a creare in una democrazia. Economisti come Joseph Schumpeter hanno da tempo richiamato l’attenzione sul fatto che democrazia non significa veramente «governo del popolo», ma che è semplicemente un sistema che offre regolarmente la possibilità di cambiare l’élite politica. Per il resto la democrazia è principalmente data da un sistema molto sottile di alternanza del controllo del potere. Orizzontalmente tra i tre poteri statali – giudiziario, esecutivo e legislativo -, verticalmente, nel caso della Svizzera, tra Confederazione, cantoni e comuni.
A questo equilibrio si aggiunge il quarto potere non statale: i media e il giornalismo. Per far funzionare il sistema dei check and balance anche questo quarto potere necessita di un controllo, che però non deve spingersi tanto da intimidire i giornalisti non permettendo loro di svolgere la propria funzione di controllo.
In un mondo ideale sarebbero quindi auspicabili pochi controlli del giornalismo attraverso la giustizia, delegando la questione ad un autocontrollo del giornalismo su sé stesso. Ma non viviamo in un mondo ideale: gli informatori più scaltri ormai sanno che, anche in condizioni di democrazia e libertà di stampa, l’assoluta protezione delle fonti non può esistere. Probabilmente la cosa migliore che resta loro da fare è il modus operandi scelto dall’informatore anonimo che in Germania ha messo alla gogna il presidente della CDU Hermann-Josef Arentz portando alla luce le sue seconde entrate. Il tempismo è stato perfetto quanto la rimozione delle prove: cinque giorni prima del congresso del partito della CDU, l’anonimo ha spedito quattro lettere alle redazioni di importanti media, usando un ufficio postale talmente grande che non sarebbe stato assolutamente possibile risalire al mittente e non lasciando, ovviamente, nemmeno un indizio sulla sua identità.
La vicenda
Ciò che ha portato Judith Miller del New York Times e Matthew Cooper del Time di fronte ad una corte federale e a rischiare fino a 18 mesi di carcere è una storia degna di un film d’azione. Protagonista involontario è un ex ambasciatore, Joseph Wilson, persona degnissima e molto stimata alla Casa Bianca. Così stimata che a lui viene affidato nel 2002 l’incarico di verificare se aveva fondamento la notizia d’intelligence secondo cui Saddam Hussein fosse in trattative per acquistare nel Niger uranio e altro materiale necessario per la produzione di bombe nucleari. La CIA aveva seri dubbi e quando Wilson tornò dal Niger il suo responso fu netto: la notizia era infondata. Ciononostante i consiglieri neoconservatori della Casa Bianca citarono il presunto acquisto di materiale atomico tra le prove anti Iraq citate da Bush nel discorso sullo Stato dell’Unione. In gennaio gli addetti ai lavori si accorsero dell’errore: il rapporto sul Niger non era stato reso pubblico, ma dopo qualche tempo dopo, nel luglio 2003, Wilson svelò i risultati della sua missione in un articolo pubblicato sul New York Times.
Ed è qui che la vicenda diventa intrigante. La Casa Bianca reagì malissimo a quel editoriale che sbugiardava l’Amministrazione e qualcuno decise di punire l’ex ambasciatore per «lesa maestà». Già, ma come? Una settimana dopo Robert Novak rivelò in un articolo che la moglie di Wilson, Valerie Plame, una bionda mozzafiato apprezzata nei salotti di Washington per la sua avvenenza e per la sua intelligenza, era in realtà un agente della CIA sotto copertura. Di fatto significava bruciare la carriera di Valerie Plame. Ma rivelare l’identità di un agente federale è un reato. E per questo venne aperta un’inchiesta: dal settembre 2003 il procuratore incaricato, Patrick Fitzgerald, indaga per appurare la verità. Deve in pratica scoprire se questa fuga di notizie è stata intenzionale e se chi l’ha causata sapeva dello status di agente segreto della Plame.
In mezzo a questi intrecci di agenti segreti, politici, ambasciatori e ritorsioni ci sono i giornalisti. Apparentemente la dritta sulla Plame non era stata data solo a Novak, ma anche ad altri giornalisti. Novak se l’è cavata dicendo di aver ricevuto la notizia da due fonti della Casa Bianca, ma non ne ha rivelato l’identità. Ha collaborato parzialmente e questo lo ha salvato. Cooper e Miller, invece, rifiutano di farsi interrogare appellandosi al Primo emendamento, nonostante abbiano ricevuto un’ingiunzione a comparire, e per questo rischiano la galera. Cooper è nel mirino del magistrato perché è il corrispondente alla Casa Bianca per Time e ha scritto sul caso Plame.
Miller, l’altra giornalista in questione, rischia la prigione addirittura per una storia che non ha mai scritto. Aveva raccolto il materiale sulla Plame, che però non si è concretizzato in alcun articolo. Questi due giornalisti in realtà non hanno infranto nessuna legge, sono stati incriminati perché qualcun altro l’ha infranta dando loro delle informazioni. Per scrivere la fine di questa storia non resta che aspettare la sentenza, che dovrebbe giungere entro qualche settimana. Il nocciolo della questione è chiaro: può un giornalista rifiutare di farsi interrogare dai magistrati per difendere le proprie fonti?
Miller e Cooper, una battaglia paradossale
La battaglia Miller e Cooper si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica in un’era in cui la «guerra al terrorismo» viene usata dai governi per limitare alcune libertà civiche e, soprattutto, di scongiurare il rischio che i giornalisti possano essere intimiditi con un abuso, da parte dei magistrati, delle ingiunzioni a testimoniare in tribunale. Miller e Cooper ritengono che l’appellarsi al Primo emendamento sia sufficiente per evitare di comparire davanti a un giudice, soprattutto se, come nel caso loro, il loro coinvolgimento nel procedimento giudiziario è indiretto: non sono stati loro, infatti, a rivelare l’identità dell’agente sotto copertura.
Eppure la loro battaglia è, in un certo senso, paradossale. Uno dei principali problemi dell’informazione odierna è la crescente ingerenza degli spin doctor – gli esperti di comunicazione al servizio dei governi – nella diffusione di notizie. Il cittadino si aspetta che le Istituzioni comunichino in modo corretto, senza ricorrere alla propaganda. In realtà, specialmente negli Usa, gli spin doctor hanno imparato a passare alla stampa notizie «ritagliate su misura», ovvero presentate in modo tale da valorizzare o difendere gli interessi del governo, spesso con scarso rispetto per la verità. Tra i metodi usati dagli spin doctor, quello più collaudato consiste proprio nel passaggio di notizie informali ai giornalisti. Oggi il New York Times e il Washington Post sarebbero a corto di notizie se non avessero proprie fonti confidenziali all’interno dell’Amministrazione. Il punto è che la gestione di queste fonti anonime è coordinata dagli spin doctor: il giornalista pensa di aver fatto uno scoop, mentre in realtà ha pubblicato una notizia che gli esperti di comunicazione dell’Amministrazione hanno fatto filtrare ad arte. Nel caso Plame c’è la quasi certezza che a passare le informazioni a Novak siano stati uomini dell’entourage di Lewis ‘Scooter’ Libby, il potentissimo chief of staff del vicepresidente Cheney e di Karl Rove, il consulente personale e mega stratega elettorale di Bush. Sia Libby sia Rove non sono nuovi a simili imprese: in passato sono stati accusati di aver manipolato il rapporto con i giornalisti. Il paradosso di Miller e Cooper consiste proprio in questo: rifiutandosi di rivelare le fonti, i due reporter proteggono gli esperti di comunicazione che abusano del rapporto fiduciario con i giornalisti e lavorano, giorno dopo giorno, per addomesticare una stampa che, paradosso nel paradosso, spesso non è nemmeno consapevole di queste insidie. La stessa Miller è stata a lungo usata dall’ex leader dell’Iraqi National Congress, Ahmed Chalabi per diffondere le notizie, poi rivelatesi false, sulle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein.