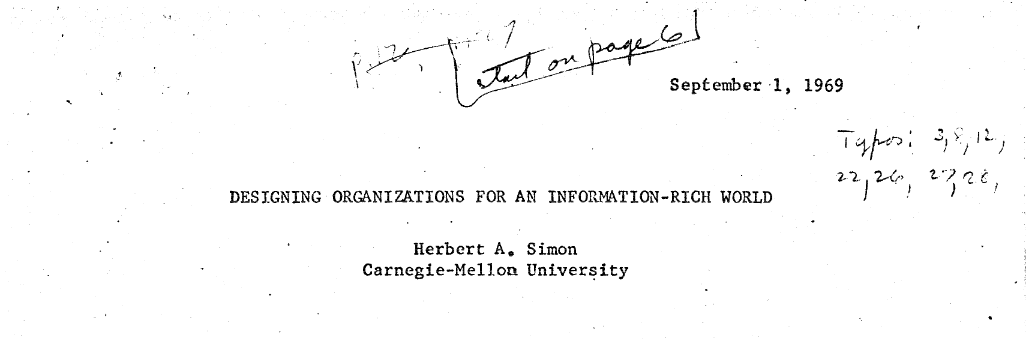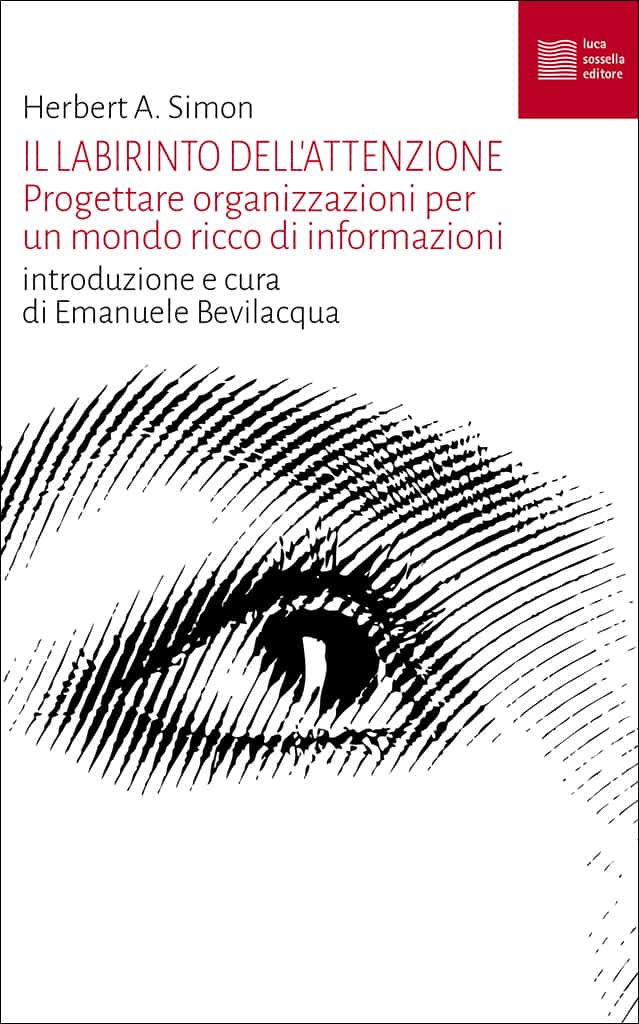Il testo di Herbert Simon qui citato è stato pubblicato con il titolo “Il labirinto dell’attenzione. Progettare un mondo ricco di informazioni”, a cura di Emanuele Bevilacqua, da Luca Sossella Editore nel 2019
Il primo settembre del 1969 l’economista Herbert Simon, professore alla Carnegie-Mellon University di Pittsburg in Pennsylvania, è pronto ad aprire la sua conferenza alla Johns Hopkins University. Nelle sue mani ha il dattiloscritto, rivisto a penna di suo pugno, dal titolo “La progettazione di organizzazioni in un mondo ricco di informazione”. Si tratta di un lavoro a suo modo storico perché suggerisce l’esistenza di una stretta relazione fra lo sviluppo del sistema informativo e la conseguente perdita di attenzione da parte del sistema stesso (produttori, gestori e fruitori di contenuti, nda). Quei mesi del 1969 sono importanti per la definizione del mondo nuovo. Agli inizi dell’anno Richard Nixon si era insediato alla Casa Bianca come 37° Presidente degli Stati Uniti. La guerra in Vietnam era al suo culmine, con oltre 500mila soldati americani sul campo.
A luglio Neil Armstrong aveva toccato il suolo della Luna. Con quel passo gli Stati Uniti avevano dato una risposta vincente alla decennale supremazia sovietica nello spazio. Nei dintorni di Bethel, nello stato di New York, si stava ancora ripulendo l’area dove si era svolto il Festival di Woodstock in piena estate, fra il 15 e il 18 agosto. Tre giorni di pace amore e sballo, una pietra miliare nella storia della musica dal vivo.
Quando Herbert Simon si appresta a intervenire nell’aula dell’Università, lo scrittore che ha segnato l’intero decennio con il suo vagabondare da una costa all’altra del Paese, Jack Kerouac, sta vivendo i suoi ultimi giorni nell’esilio di St. Petersburg, in Florida. L’autore di On the Road, posseduto dall’alcol, morirà nel bagno della sua villetta il 21 ottobre di quello stesso anno. A nulla servirà un ricovero e un disperato tentativo di salvarlo dalle conseguenze di una emorragia interna.
Si chiudono così gli anni ’60. Se l’osserviamo dalla prospettiva dei nostri giorni, è forse allora che si chiude davvero il secolo breve delle rivolte, delle trasgressioni, dei sogni. A ottobre di quell’anno partirà il primo, incerto collegamento Internet, con quel messaggio mozzo: “lo” (completo doveva essere “log in”, nda). Saranno gli adolescenti di quegli anni a inaugurare il secolo delle tecnologie, che si apre con i primi oggetti inventati da Steve Jobs, figlio della controcultura e padre della tecnologia domestica, a metà degli anni Settanta.
Quella mattina del primo settembre 1969, Herbert Simon si prepara a intervenire sul tema delle organizzazioni aziendali nella nuova società dell’informazione. L’argomento della relazione appare molto tecnico, ma l’economista sorprende tutti i presenti con un intervento che mostra una straordinaria lucidità nell’immaginare i rischi di una gestione non consapevole della tecnologia e dell’informazione. Una visione tuttavia aperta e non apocalittica come invece abbiamo potuto leggere nelle narrazioni di George Orwell di 1984 o a quelle di Arthur C. Clarke di The Sentinel, racconto seminale per 2001 Odissea nello spazio, film di Kubrick del 1968. Herbert Simon ha tuttavia poco a che vedere con le narrazioni. Si occupa di economia, di organizzazione aziendale, di psicologia, di intelligenza artificiale. Nel 1978 gli verrà assegnato il Nobel per l’economia.
Così Simon prende il microfono e afferma: “È arrivato il momento di occuparci delle conseguenze che la tecnologia può avere nelle nostre vite. L’evoluzione tecnologica procede a grandi passi, ma non accade lo stesso alla nostra capacità di analizzarne le conseguenze. Dovremmo forse testare le nuove tecnologie, prima di renderle disponibili a tutti. Forse in questo modo faremmo meno danni”.
E poi, da economista, ma anche da studioso attento alla natura umana, si occuperà anche di psicologia, Simon propone una relazione strettissima fra lo sviluppo di una società dell’informazione e la nostra capacità di star dietro all’abbondanza di dati. Lo fa partendo da un esempio folgorante. Dice Simon: “Recentemente, i miei vicini di casa hanno regalato due conigli alla loro bimba in occasione del suo compleanno. Casualmente, o forse no, i conigli erano uno maschio e l’altro una femmina. Ora vivo in una società ricca di conigli! Ma si dà il caso che quando c’è ricchezza di un elemento, necessariamente ci deve essere mancanza di qualcos’altro. Infatti ora nel mio giardino c’è scarsità di lattuga. Era inevitabile!”.
Simon va così al punto. E parla di tutti noi, non più solo della bimba, dei conigli e della sparizione della lattuga. “In una società ricca d’informazione deve dunque mancare qualcosa: questo qualcosa è l’attenzione”. Ecco fotografata, con decenni di anticipo, la nostra esistenza, nel secolo delle tecnologie e dell’informazione.
Da quel settembre del 1969 sono passati più di 50 anni. E l’intuizione di Simon è confermata. Oggi siamo molto più ricchi di informazione di 50 anni fa, di 5 anni fa. Seguendo Simon, possiamo confermare che la nostra attenzione è calata di conseguenza. La mancanza di attenzione sta modificando i nostri stili di vita, i consumi culturali, la nostra capacità di apprendimento, sta facendo crollare il modello di business tradizionale dell’industria televisiva, di quella editoriale e dei media in generale.
In aggiunta, impedisce un sano sviluppo del digitale, strozzato da un paradosso imprevedibile fino a pochi anni fa. Il mercato dei contenuti digitali coinvolge un pubblico sterminato, quasi 3,4 miliardi di persone nel mondo, ma che, per la gran parte, non è disposto a spendere per i contenuti che riceve.
Da sempre abituati a consumare contenuti gratis dalla rete, facciamo fatica a pagarli. Siamo così al paradosso che le poche centinaia di migliaia di lettori che ancora comprano The New York Times in edizione stampata pagano 21 dollari a settimana per poterlo leggere su carta, i milioni (quasi 5) di lettori che leggono gli articoli dal quotidiano in digitale, lo fanno per meno di 2 dollari a settimana, se sono abbonati. Il digitale sembra valere ancora poco per il lettore e di conseguenza anche per gli investitori pubblicitari, anche loro disposti a pagare pochissimo per i loro annunci, spot e video promozionali.
La rete oggi consente di misurare tutto, quanto tempo passiamo su un sito o nella lettura di un ebook. Come sappiamo, i numeri sono deludenti. Il tempo medio di permanenza nei siti si misura spesso in secondi, di rado si supera il minuto. E questo sta facendo crollare l’illusione di un pubblico attento e concentrato su quanto sta seguendo. Un pubblico che forse non esisteva nemmeno nell’era della carta stampata e della tv tradizionale, ma allora era più difficile misurarne i comportamenti.
Ecco dunque la spirale perversa del digitale da cui è difficile uscire. Tanto pubblico ma distratto, tanto spazio per la pubblicità, ma poco valore aggiunto. Così oggi i produttori di contenuti più avveduti (complicato chiamarli ancora editori), stanno cercando di dar valore non più al numero di lettori, visitatori, clienti che riescono a intercettare, ma al tempo che questi dedicano online. Certo, il tempo dedicato non necessariamente significa attenzione, ma da qualche parte bisogna pur cominciare, se si vogliono rivedere le proprie strategie, se si vuole ricostruire una nuova economia dei media.
Abbiamo un comparto, quello dei vecchi media, si pensi in particolare alla stampa, che continua a perdere copie, pubblicità e lettori e un segmento digitale che vanta un pubblico certamente enorme, formato da individui che passano pochi secondi sui siti o nelle app e che sono poco disposti a pagare per i contenuti che ricevono. Questo genera un mercato pubblicitario insufficiente a garantire un sano sviluppo del settore. Per superare tutto ciò è necessario valorizzare e far crescere una audience che invece dedica più tempo ai contenuti, soffermandosi nella fruizione di argomenti che richiedono più tempo e attenzione. Va poi soprattutto dimostrato ai potenziali investitori pubblicitari che, anche nel digitale, è possibile individuare target di qualità.
Sono ormai diversi anni che i principali media, fra questi The New York Times, The Guardian, The Economist, stanno sperimentando piattaforme tecnologiche in grado di profilare meglio il proprio pubblico, con lo scopo di definire quali contenuti e argomenti, e quali approcci giornalistici, possono consentire di aumentare il valore dei loro siti.
L’analisi dei dati prodotti da queste piattaforme consente di studiare quasi in tempo reale le reazioni dell’audience ai temi trattati e a come vengono loro rappresentati. E, di conseguenza, fornire agli inserzionisti pubblicitari elementi utili per investire meglio il loro denaro. Siamo solo agli inizi, ma la strada sembra essere questa appena descritta. A patto di superare un altro ostacolo che appare per ora insormontabile e che conferma l’intuizione di Herbert Simon.
Le ricerche, ormai numerose, sulla lettura digitale, evidenziano una difficoltà dei lettori a mantenere lo stesso livello di comprensione, ricordo ed empatia, riscontrabile invece nei lettori della carta. Segnaliamo, fra i tanti, i lavori di Nick Seaver alla Tufts University, con il suo seminario “How to Pay Attention”, e di Katherine Hayles con il suo saggio Unthought: The Power of The Cognitive Nonconscious (University of Chicago Press, 2017).
In attesa di un lettore digitale in grado di godere di un testo come quello tradizionale, sembra proprio che la ricchezza di informazione debba portare con sé un conseguente impoverimento della nostra attenzione. Superare questo gap è la vera scommessa da vincere nell’immediato futuro, per una piena economia digitale. Comunque, se è lecito parlare di “Economia dell’attenzione”, certo è da Herbert Simon che occorre partire. Vediamo quali sono i punti di interesse nella lezione di Simon in quel lontano settembre del 1969.
Dentro l’economia dell’attenzione
Per prima cosa, Simon chiede al suo pubblico e quindi anche a noi, audience remota e digitale, di metterci d’accordo sull’uso dei termini. Simon ci avverte che userà parole d’uso comune, come informazione, pensiero, organizzazione, termini che però nel corso degli ultimi 25 anni, ci segnala, hanno acquisito nuovi significati scientifici. In un certo senso anche noi dovremmo per prima cosa riflettere su quanto termini come questi accennati, abbiamo ampliato, nei 50 anni che ci separano da quella conferenza, la loro tensione semantica.
Non c’è dubbio che ci sia stata una trasformazione di senso. E possiamo valutare quanto questa mutazione sia ancora in una fase di accelerazione. Quando Simon parla di “machine think”, siamo certi che intenda quanto oggi noi percepiamo come significato di questa espressione? Come ci fa notare, lo stesso termine “think”, crea non pochi problemi di messa a fuoco del suo significato. Pensare, ci ricorda Simon, per noi significa descrivere una serie di processi in parte intuitivi, in parte subconsci, talvolta creativi.
Come non condividere con Simon la considerazione che bisogna evitare di commettere errori sul significato di queste mutazioni di senso? Sono mutazioni che segnalano un cambio del nostro modo di pensare. Quel che è certo è che a parte casi di rifiuto delle competenze specifiche nel segmento della scienza e della tecnologia, tutti noi abbiamo imparato a maneggiare con una maggiore precisione scientifica termini come informazione, pensiero, memoria, processi decisionali.
Questo comporta una diversa consapevolezza del peso della scienza nella cultura generale. Simon si chiede poi da quanto tempo possiamo considerare il mondo ricco d’informazione e quali siano le conseguenze di questa prosperità. E qui, da vero mago, tira fuori dal suo repertorio, la parabola dei conigli cui facevamo accenno prima. La connessione fra la propagazione dei conigli a quella dell’informazione è veloce e intuitiva. Dice Simon che anche la ricchezza di informazioni crea un deficit, questa volta di attenzione. Questa situazione impone la necessità di ridefinire tale attenzione in modo efficiente, tra la sovrabbondanza di fonti di informazione che potrebbero consumarla. Impresa non da poco, come ben sappiamo.
Simon si concentra su un aspetto decisivo: come misurare l’attenzione. Considera non possibile utilizzare la misurazione in bits che Claude Shannon aveva codificato nel suo saggio “Una teoria matematica dell’informazione” (Bell System Technical Journal, 1948). L’attenzione va calcolata in ore e minuti, dice, pur riconoscendo i fortissimi limiti di questo calcolo.
Va tenuto presente, e del resto è molto chiaro leggendo il testo di Simon, che l’autore non pensa solo al fruitore finale, ma anche e soprattutto all’human executive, che deve filtrare, orientare e smistare flussi informativi aziendali. L’aumento del flusso informativo e la conseguente caduta dell’attenzione non è quindi da considerare solo come una caratteristica del pubblico, dell’audience, ma anche di chi l’informazione la maneggia e la forma.
Qui vediamo come il tema dell’attenzione leghi in modo molto forte l’operatore e il destinatario finale. Se facciamo riferimento all’industria dell’informazione e dei media, dovremmo concludere che produttori e fruitori sono tutti dentro l’algoritmo flusso informativo/attenzione. In sostanza non è solo il pubblico a subire un calo di attenzione in presenza di forti stimoli informativi, ma anche chi l’informazione la produce. Con le conseguenze che possiamo immaginare e che forse è il caso siano oggetto di studio specifico.
Non ci sono elementi per affermare, in linea generale, che la stessa ricchezza informativa, in presenza di un forte calo di attenzione nel suo ciclo industriale, possa indirettamente produrre contenuti meno accurati. Certo, anche qui si apre una linea di analisi e approfondimento che andrebbe sondata. Sappiamo bene, oggi, quanto una correlazione quantitativa sia del tutto insufficiente per valutare una caratteristica prevalentemente qualitativa come l’attenzione. Questo quando si ha a che vedere con l’utilizzo di mezzi elettronici (radio, tv), ma soprattutto per quanto riguarda tutto l’universo del digitale.
Numerose ricerche sia quantitative sia qualitative hanno confermato quanto sia correlato il rapporto fra esposizione all’informazione e capacità di attenzione. È questa una questione di straordinaria delicatezza. Gli studi in proposito cominciano a essere numerosi, come abbiamo ricordato. Nel testo di Simon troviamo una nuova sorpresa di grande interesse. Simon non si accontenta di un dato che tendiamo a dare per scontato. E cioè che il costo di produzione sia sostenuto da chi, per esempio, produce e distribuisce un giornale. Non basta. Simon sostiene che noi dobbiamo sapere anche quali siano i costi sostenuti dagli acquirenti per leggere quel giornale. Anche in termine di scarsa attenzione. Allora il costo (e il valore?) di un giornale sarà quello sostenuto dal suo editore più quello sostenuto dal lettore impegnato nella lettura.
Da uomo pratico Simon chiede ad alcuni amici di provare a calcolare il costo della loro lettura. Non spiega purtroppo quale sia il metodo di questo calcolo. Quel che colpisce nel ragionamento di Simon, se lo accettiamo così come lo ha presentato, è che ci offre un metodo totalmente diverso dall’usuale per calcolare il valore di un contenuto informativo. Ne potremmo dedurre che una parte preponderante del valore complessivo (acquisto e lettura) del giornale dipende dalla attenzione del lettore. E da questa attenzione dipende anche indirettamente il prezzo di vendita del giornale e, a ben vedere, il valore degli spazi pubblicitari proposti dalla pubblicazione.
Questi ultimi sono tanto più efficaci, quanto più la somma dei lettori dedica tempo e impegno nella lettura del prodotto giornale. Solo en passant faccio notare che, se ricordiamo che il tempo media di lettura sul web si riduce a 40 secondi (contro i 40 minuti della lettura su carta), troviamo una spiegazione aggiuntiva del perché gli spazi pubblicitari online valgano così poco e producano così poco fatturato, nonostante l’enorme quantità di visitatori in più rispetto al media tradizionali.
Il pubblico online partecipa in misura ridotta alla produzione di valore aggiunto, perché di molto inferiore è il tempo dedicato alla lettura digitale e di conseguenza è minore l’attenzione dedicata. Come sappiamo, le motivazioni del basso valore degli spazi pubblicitari on line sono più complesse e articolate. Tuttavia questo aspetto del valore del tempo dedicato dal pubblico e il suo valore, andrebbe meglio analizzato in tutto il suo spettro di diramazioni.
Ciò che Simon tiene a far sapere, è che i suoi amici, dopo aver calcolato il costo della loro lettura, “hanno dimostrato notevole allarme, ma non hanno cancellato i loro abbonamenti”. Hanno reagito a un (apparente) aumento del costo dei loro giornali con sgomento, ma da lettori soddisfatti, non hanno rinunciato alla lettura, confermando i loro abbonamenti, nonostante la nuova consapevolezza dei costi.
Una sperimentazione, quella di Simon, che è rivelatoria questa volta dal punto di vista del marketing. Trova indiretta conferma infatti in un’osservazione fatta sul campo, specialmente in Gran Bretagna e Usa, dopo la crisi economica del 2008. Il lettore fedele non abbandona il proprio giornale in presenza di un aumento del prezzo, lo fa invece se deluso dalla qualità di quello che trova nel suo giornale. In estrema sintesi, i giornali che hanno risposto alla crisi di vendita e di pubblicità aumentando il prezzo dei loro giornali, sono riusciti a reggere meglio, quelli che hanno preferito tagliare i costi (e quindi, almeno in parte il livello dei loro contenuti) hanno visto scendere più velocemente le copie e il fatturato pubblicitario.
Veniamo ora a un argomento nella conferenza di Herbert Simon di grande rilevanza. Simon concentra la sua relazione su una questione che ha studiato a lungo, l’analisi delle strutture organizzative complesse, come per esempio possono essere le agenzie governative. In questo caso fornisce una serie di riflessioni su come si possa far rendere al meglio la scarsa attenzione di chi, dentro strutture appunto complesse, si trova a dover valutare, elaborare e smistare una enorme mole di materiale informativo. “Noi dobbiamo distribuire la nostra attenzione attraverso diverse classi di attività”, ci ricorda Simon.
Queste classi sono quattro: 1) l’ascolto, 2) la conservazione, 3) il pensiero, 4) la parola.
Un sottosistema di elaborazione delle informazioni (rete, nuova unità organizzativa), ridurrà la domanda netta di attenzione del resto dell’organizzazione solo se assorbe più informazioni, precedentemente ricevute da altri, di quelle che produce, se ascolta e pensa più di quanto parli. Ma quante e quali informazioni è possibile estrarre dal sistema che le produce o le rielabora?
Simon pensa sempre alle organizzazioni complesse di carattere statale o governativo, ma qualsiasi efficiente produttore o distributore di contenuti di medie dimensioni si trova oggi nella situazione appena descritta.
Media e social media si occupano di: 1) creare, ricevere e archiviare informazioni che altrimenti potrebbero finire disperse o non valorizzate; 2) organizzare e filtrare le informazioni in un output che richiede meno ore di attenzione rispetto alle informazioni di input.
Simon ci ricorda infatti che produrre e distribuire contenuti quando le informazioni sono scarse e devono essere preservate è molto diverso dal progettarle secondo il principio “più informazioni sono migliori”. Lo scopo non è quello di portare al pubblico tutte le informazioni necessarie, ma di riorganizzare l’ambiente in modo da ridurre il tempo che il pubblico deve dedicare alla ricezione. Simon descrive un comportamento che non appartiene all’epoca che stiamo vivendo, quando dice che una generazione che non è in grado di buttar via un libro rilegato e che ha problemi perfino a liberarsi di riviste e giornali, rifletta una cultura della povertà.
È vero che ancora oggi alcuni sono così ossessionati dalle informazioni da leggere o conservare tutto quello che capita a tiro. Ma si tratta di specie forse destinate all’estinzione. Dove invece, a mio avviso, sopravvive questa cultura della povertà informativa è invece in alcuni media (quotidiani in particolare) che non riescono a liberarsi del terrore di bucare una notizia, quando la struttura stessa dell’informazione stampata, in presenza di social, news online, dovrebbe suggerire un approccio diverso e più aperto all’informazione. Liberarsi di questa forma di ossessione produrrebbe giornali migliori, ma non tutti riescono a farlo.
Qui rischiamo di allontanarci da Simon. O forse no, quando ci ricorda che il significato del termine “conoscere” sta sempre più scivolando verso un nuovo senso: avere accesso. Oggi diremmo che stiamo passando dal possesso all’uso delle informazioni. Ci ricorda qualcosa? Possiamo avere informazioni senza averne accesso (documenti e lettere non archiviati, una biblioteca senza indice) o viceversa avere accesso senza averne un archivio, è quello che accade quando ci misuriamo la temperatura, quando usiamo un software open source e più in generale nel web.
Simon concentra poi la sua attenzione sulla ridondanza. Veste i panni del bibliotecario e riflette: se una biblioteca possiede due copie dello stesso libro può tranquillamente scambiare o eliminare una delle due copie senza far perdere informazioni al suo sistema. Una delle due è ridondante. Simon ci ricorda che questa appena descritta è solo una, la meno rilevante, delle tre forme di ridondanza nell’informazione. Infatti anche se la biblioteca possiede solo una copia di ogni libro, è molto probabile persista comunque una sovrapposizione di informazioni fra il contenuto di ogni singolo libro e il resto della biblioteca. Anche archiviando solo una parte dei volumi avremmo comunque una piena conoscenza anche dei volumi non presenti. Una quota dei libri può prevedere gli altri.
Simon porta l’esempio della Library of Congress di Washington e afferma: “se la metà dei titoli selezionati a caso, fossero distrutti, solo una piccola parte della conoscenza sarebbe perduta per la biblioteca”. Possiamo dunque stabilire che una selezione dei titoli e una capacità di valutarne contenuti e collegamenti può permettere di ridurre la quantità di informazioni che devono essere lette, scritte o archiviate. Pensare di poter conservare una memoria di tutto è un sogno per Simon, ma “un sogno amletico malato”.
Dobbiamo considerare non solo i limiti del pensiero umano, ma anche “la scarsità dell’umana attenzione”, come fa notare Simon: “la tecnologia non può risolvere tutti i nostri problemi e aspettative”. Quel che serve è una continua valutazione tecnologica e la capacità di prevedere in anticipo quali innovazioni possono essere negative per lo sviluppo umano. Come appare chiaro da questa relazione, Simon crede fermamente nella tecnologia come propulsore per l’innovazione, si fida meno degli uomini e della loro capacità di valutarne gli effetti con sollecitudine e attenzione. E lo afferma con una certa schiettezza quando dice: “per esser chiari, un continuo monitoraggio tecnologico ci permette di sostituire la previsione al ‘senno di poi’”. Più chiaro di così!
Per non lasciare il dubbio al lettore che si sia forzato il pensiero di Simon, possiamo attingere direttamente dalla sua autobiografia, Models of my Life (Basic Books, 1991) e tradotta anche in italiano da Rizzoli nel 1992 anche se oggi introvabile. Nel corso del capitolo “Ricerche a Berkeley”, Simon scrive:
“Attorno al 1945, mentre insegnavo all’Illinois Institute of Technology, feci una revisione della mia tesi, la feci circolare per sentire commenti, la revisionai di nuovo, trovai un direttore editoriale disposto a rischiare la pubblicazione (Donald Porter Geddes della MacMillan) e la pubblicai nel 1947. L’opera era costruita intorno a due idee correlate che sono sempre state alla base di tutta la mia attività intellettuale: 1) che gli esseri umani sono in grado di raggiungere solo una forma di razionalità molto limitata, e
2) che in conseguenza dei loro limiti cognitivi sono inclini a identificarsi con obiettivi secondari.”
Fin qui Simon nella sua autobiografia. Il testo citato è Il comportamento amministrativo (edito in Italia da Il Mulino) dove si legge: “Non è quindi la razionalità a determinare il comportamento. All’interno dell’area della razionalità il comportamento è perfettamente flessibile e adattabile a capacità, obiettivi e conoscenze. Il comportamento, invece, è determinato dagli elementi irrazionali e non razionali che circoscrivono l’area della razionalità. L’area della razionalità è quella dell’adattabilità a questi elementi non razionali”.
Herbert Simon nel digitale
Non è il caso qui di fare la storia dei miei media, ma ho avuto la fortuna di far parte di tante esperienze, comprese start up, spesso eccitanti. Vorrei solo restituire a un pubblico più giovane, una constatazione. Alla fine la vita professionale è spinta da due fattori essenziali: la nostra curiosità avventurosa e la storia che ci gira intorno. Se sei adolescente nell’epoca delle proteste giovanili, del rock’n’roll e delle radio private, se il tuo primo computer l’ha pensato il giovane Steve Jobs, se prima dei 30 anni qualcuno fonda MTV e sei coetaneo di Tim Berners-Lee, che lancia il World Wide Web, è difficile star fuori dall’onda. Ti ci devi buttar dentro con tutta la forza e l’energia che hai a disposizione. Questo è quello che una parte della mia generazione ha fatto. Questo è quello che ho fatto.
I corsi tenuti all’Università della Svizzera italiana (USI), dall’autunno del 2005, sono stati per me l’occasione per sistematizzare e riorganizzare (muovendomi dalla pratica alla teoria), un lungo operativo nelle aziende che producono contenuti, tradizionali, digitali. Il tema dell’economia dell’attenzione si è fatto largo da solo. Man mano che scorrevano gli anni di lavoro intorno al corso e dunque agli aspetti economici dei media, il tema acquisiva spazio nelle lezioni. Negli ultimi anni, da una serie di conversazioni con il Professor Matthew Hibberd, è nata l’idea di un corso sperimentale in “Economia dell’attenzione”. E di questo e altro gli sono molto grato.
Qui ora è importante qualche breve premessa a proposito dei principali eventi che hanno segnato il percorso dei media negli ultimi anni. Dagli anni 2000 a oggi accadono alcune cose che modificano profondamente il modello di business di radio, giornali, tv e anche dei nuovi oggetti digitali di cui progressivamente si conoscono potenzialità e limiti.
- La centralità del web (dal 2000).
- La scelta strategica e consapevole dei media tradizionali (soprattutto i giornali) di puntare tutto sul digitale, fornendo contenuti gratuiti con l’obiettivo di spostare il pubblico dei lettori dalla carta al digitale e di incassare così, prima o poi, nuova pubblicità sul web. Dal 2004 e in modo esplicito dall’editoriale della primavera del 2006 firmato da Alan Rusbridger, all’epoca direttore del Guardian.
- Arrivo immediato crisi economica a seguito della bolla dei sub-prime (autunno 2008).
- Ceollo della economia tradizionali del media per effetto della crisi: meno vendite, abbonamenti e pubblicità (2008/2010).
- Conseguente mancato decollo dei fatturati pubblicitari (frenato dalla crisi)
- Crescita esponenziale di nuovi giganti dei media (Google, Facebook) che impongono un nuovo stile di raccolta delle risorse pubblicitarie. (dal 2004).
- Lo sviluppo delle app, un mondo privatistico che affianca un Web pensato come libero e gratuito (dal 2010).
- Uno sviluppo reso possibile da un progressivo spostamento verso l’uso dello smartphone rispetto ad altri supporti: computer, tablet, consolle, etc. (dal 2010).
Siamo così arrivati ai giorni nostri, in pieno paradosso digitale. In rete troviamo tanti visitatori, tanto pubblico, tanti consumatori, tutti distratti e disposti a pagare poco per contenuti e servizi. Questo genera una scarsa attenzione alla qualità del materiale informativo della rete e scarso valore della pubblicità in rete, che non basta da sola a garantire equilibrio alle nuove aziende.
Che fare?
C’è chi ha trovato il modo di sopravvivere, alcuni degli operatori più qualificati e credibili lo hanno fatto incrementando i prezzi dei servizi tradizionali (abbonamenti, prezzi di copertina, canoni). Solo chi offre un prodotto di qualità può provare ad alzare le tariffe. Sa che perderà una parte del pubblico, ma che conserverà quella più fedele e interessata ai contenuti. E l’incremento del prezzo sarà sufficiente per guadagnare ampiamente, nonostante la perdita di una quota della clientela. Chi produce contenuti poveri o recuperabili altrove non può far altro che intervenire sui costi, tagliando così anche una quota importante della qualità residua della propria offerta.
Il pubblico dei media tradizionali è infatti più fedele e più disposto a pagare per contenuti di qualità. E pochi altri, che hanno trovato un nuovo, instabile equilibrio fra tradizione e digitale. Ognuno con la propria storia di successo non sempre replicabile, qui gli esempi sarebbero diversi, ma valga per tutti il caso del mensile The Atlantic, storica rivista, da tempo in crisi. Negli ultimi tempi The Atlantic ha vissuto una seconda giovinezza grazie alla decisione di affiancare alla carta ben cinque siti tematici che hanno non solo contribuito a riportare i bilanci in attivo, ma anche a rilanciare indirettamente il mensile tradizionale.
Da qualche anno la società che pubblica The Atlantic è stata acquisita da Laurene Powell Jobs, vedova del fondatore di Apple. Quel che appare chiaro è che al centro di qualsiasi business passato e futuro devono esserci contenuti di qualità. Sembra una banalità, ma la maggior parte dei media che non sono riusciti a superare le difficoltà, hanno scelto la strada apparentemente più semplice, ma senza ritorno. Vale a dire tagliare i costi sperando che superata la crisi e le difficoltà conseguenti, tutto potesse tornare come prima.
Come si verifica la capacità di attirare l’attenzione di un pubblico digitale? La tendenza dominante è sempre stata (e ancora lo è) è quella di contare le teste, vedere quanto pubblico arriva non vuol dire necessariamente apprezzamento. Come misurare allora l’attenzione? Restiamo per un momento ancora su The Atlantic, perché ci fornisce un caso di interesse. Nel 2015 il periodico pubblica una serie di articoli dedicati all’Isis, “What the Isis Really Wants”. Si tratta di un’inchiesta molto approfondita e ben costruita dal reporter Graeme Woods.
La serie viene pubblicata sul mensile e in digitale. Dopo breve tempo The Atlantic dichiara che la serie ha battuto un record: se si considera il tempo di lettura totale che il pubblico ha dedicato agli articoli, siamo davanti al contenuto che ha avuto il più alto tempo medio di lettura (3 minuti medi) e il più alto numero di pagine viste (oltre 20 milioni). Quindi non il numero maggiore di contatti, né di visitatori, ma il tempo complessivo più alto di lettura. Un record che fa riflettere. E se attraverso questo parametro si riuscisse a stabilire l’attenzione media che il pubblico dedica a un contenuto? E, attraverso questo, trovare un modo per misurarne il gradimento? Potrebbe essere questo un modo più efficace per “vendere” gli articoli ai lettori e agli inserzionisti sul web (e in digitale)?
Sia lettori che inserzionisti, abbiamo imparato, sono poco disposti a pagare per contenuti e pubblicità online. Ora principali media, fra quelli che producono contenuti di qualità, hanno messo al centro del progetto questo obiettivo: studiare argomenti, contenuti e stili di presentazione che riescono a catturare meglio e per più tempo l’attenzione dei lettori e valorizzare il più possibile questa informazione.
Il circolo virtuoso da creare è, grazie alle piattaforme digitali e i big data, servire meglio il pubblico e poter orientare gli investimenti pubblicitari non più sul numero di teste connesse, ma sull’attenzione e la soddisfazione che questi contenuti riescono a produrre. Sembra facile ma non lo è, occorrono investimenti importanti e lungimiranza nel voler ricostruire dalle fondamenta un rapporto solido con il proprio pubblico. Questo significa rimettere in gioco tutto, compreso il proprio modo di pensare l’informazione. Ci sono esperienze importanti che vanno in questa direzione.
Ecco dunque perché usare il testo di Simon come riferimento. L’Economia dell’attenzione può essere intesa come lo studio e la formalizzazione di alcune pratiche: 1) La capacità di fornire contenuti di valore, alle giuste tariffe in modo che tutte le parti in questione siano soddisfatte; 2) Evitare la dispersione di attenzione di tutta la catena produttiva, da chi realizza i contenuti fino a chi li consuma.
Cioè l’esatto contrario di quanto accade oggi. È in questa direzione che va anche intesa una seria battaglia contro i monopoli digitali che concentrano risorse economiche e di attenzione senza saperle redistribuire e organizzare. È possibile immaginare allora una economia dell’attenzione, non un marketing dell’attenzione come nei fatti è stata intesa la materia per anni? Quel che cercavo per il mio corso a Lugano era una riflessione teorica sulla Economia dell’attenzione. Perché è chiaro che il lavoro svolto in questi ultimi anni da numerosi analisti e aziende che producono contenuti, consiste nel mettere in relazione l’attenzione (non solo il tempo, dalle audience al consumo di contenuti) con gli aspetti economici di questa attività (fidelizzazione, vendita di spazi pubblicitari, sponsorizzazioni, abbonamenti, sottoscrizioni).
L’interesse era di comprendere se questa necessità pratica avesse avuto qualche forma di organizzazione teorica o se era semplicemente sgorgata come acqua dalla roccia. E gli spunti non mancano. Una riflessione la troviamo in Georg Franck e il suo “The Economy Attention” (1999) pubblicato in Germania su Merkur, no. 534/535 e tradotto in inglese da Silvia Plaza. Circa dieci anni più tardi, ormai in piena era digitale, ecco un nuovo spunto di rilievo. È un testo di Kevin Kelly, uno dei guru della cultura digitale, a lungo direttore di Wired. Il testo completo si trova in rete, nel sito di The Edge, con il titolo “Better than Free”. Kelly ragiona sul concetto di gratuito nel digitale. È un testo famoso e molto commentato, Kelly individua otto elementi generativi che non possono essere copiati e come tali hanno un valore – “better Than free”, dice appunto – nonostante la facilità della rete di proporci contenuti gratuiti e facilmente copiabili. Per non deludere la curiosità del lettore li elenco, ma dico subito che l’aspetto interessante è altrove nel testo.
Questi elementi sono: immediatezza, personalizzazione, interpretazione, autenticità, accessibilità, fisicità, mecenatismo, rintracciabilità. E a poche righe dalla fine del testo, buttate lì, all’apparenza troviamo una frase, incompleta, intuitiva e folgorante, che richiede di essere raccolta: “per farla breve, il danaro, in questa economia in rete non segue il sentiero delle copie. Piuttosto segue il sentiero dell’attenzione. E l’attenzione ha i suoi circuiti”. Veniamo allora all’incontro con il lavoro di Herbert Simon, che aveva intuito già nel 1969 l’importanza di misurare e valorizzare la nostra attenzione.
Il nome di Simon lo trovo in nota, più volte, in diversi lavori. Il testo “Designing Organizations” nelle citazioni porta la data del 1971. Con un po’ di ricerca sul sito della sua università, la Carnegie Mellon, dove è custodito un fondo dei lavori realizzati dall’economista, trovo in pdf la versione dattiloscritta e corretta a mano di suo pugno, della versione effettivamente letta quel settembre del 1969. Le citazioni dimostrano che la rilevanza del testo è dunque stata notata da diversi autori e da diverso tempo. E un lavoro però messo in bibliografia ma non molto commentato, né, sembra, letto con la dovuta attenzione. Eppure gli spunti presenti, come abbiamo visto sono molteplici.
Herbert Simon passa da toni leggeri a dettagliati suggerimenti su come debbano essere organizzate le strutture complesse o come debba essere trattata l’informazione di base, per evitare una eccessiva dispersione dell’attenzione da parte degli utenti e una conseguente dissipazione dei contenuti. È tutto quanto mai attuale e necessario in questa nostra esperienza digitale. Non è però un tema di conversazione, ma un’occasione di studio e di approfondimento. Le esperienze non mancano, come accennavo, ora forse si tratta di metterle insieme e provare una sintesi.
In conclusione possiamo dire che l’Economia dell’attenzione richiede un riallineamento fra teoria e pratica. Simon ha fornito la scintilla, un primo inquadramento teorico, senza aver generato direttamente una pratica. Oggi, come abbiamo accennato, esistono pratiche diffuse senza che queste abbiano trovato il percorso per collegarsi alle riflessioni del passato. Ci auguriamo di aver dato un piccolo contributo concreto utile per avviare questa connessione.