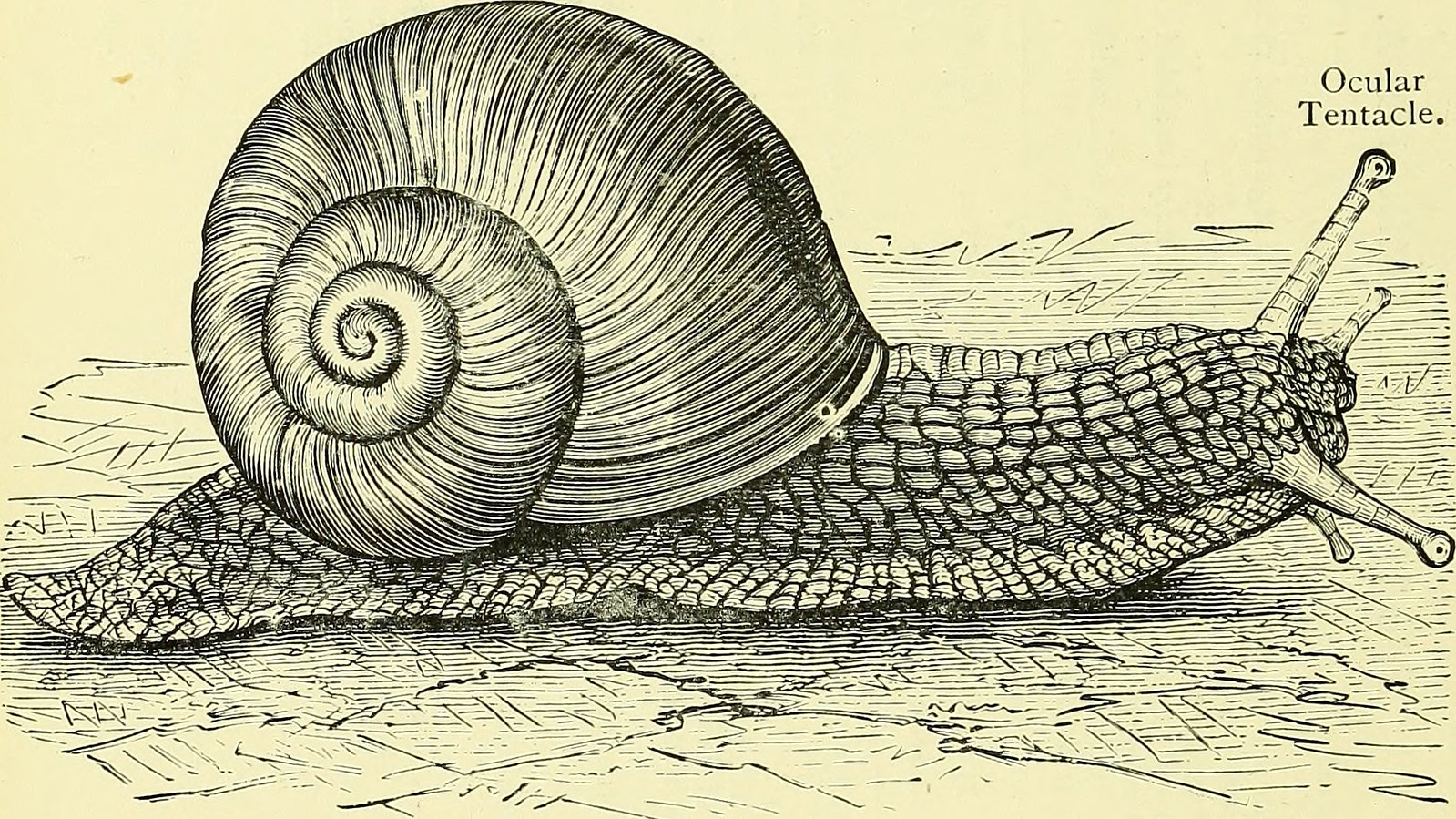
“Elementary text-book of zoology [electronic resource]” (1901) / Internet Archive Book Images / Flickr CC
La difficoltà principale che si incontra nel definire lo slow journalism è che, naturalmente, nasce per contrasto e contrapposizione rispetto al fast journalism, cioè a quel giornalismo che si preoccupa più che altro degli spazi da riempire (sulla carta, nell’etere, sul web) invece che di proporre contenuti quando sono pronti per essere fruiti. Ovviamente, nasce per contrasto anche al modo con cui molti giornali, andando alla caccia ossessiva del click, hanno scelto di interpretare il digitale.
Ci sono alcuni elementi fondamentali del giornalismo tradizionale che lo slow journalism critica:
– Il rapporto con il pubblico: lo slow journalism si rivolge a una comunità di persone che tratta da pari, che tratta come “esperti”, con cui si relaziona. Questo non significa che chiunque sia giornalista, ma che il giornalista non è onniscente. L’onniscenza, invece, è tipica soprattutto del giornalismo italiano e la distanza dagli interessi del pubblico è tipica di un’industria che ha fatto fatica a considerarsi come un prodotto-servizio. Trasparenza, relazionalità e fiducia dovrebbero essere al centro di un ripensamento di questo rapporto, la cui riprogettazione – magari utilizzando tecniche mutuate da altre industrie, come il design thinking, per mettere al centro le persone – diventa vitale.
– Il modello di business: la scelta più radicale dello slow journalism è quella di distaccarsi completamente dal mondo della pubblicità. Gli interessi di inserzionisti e editori oggi divergono. E gli inserzionisti non hanno mai avuto come primo interesse quello di avere un pubblico più informato. È chiaro che sia una scelta che, se condivisa, per i legacy media dovrebbe prevedere un percorso graduale. Più immediata, invece (anche se non certo più facile) per le startup giornalistiche.
– Il modello produttivo e le metriche: in un’era di sovrapproduzione di contenuti che competono per attirare l’attenzione delle persone, il giornalismo mainstream non ha saputo trovare un modo per ridurre la produzione quantitativa a scapito della qualità, in questo supportato dalla scelta di metriche pessime, perlopiù quantitative, appunto, per valutare la qualità del lavoro giornalistico. Si inondano le piattaforme (la carta, l’etere, il web) di contenuti in un ciclo continuo, senza sosta, malato di “istantismo”.
Da queste critiche e considerazioni discende un percorso che porta ad affrontare un’altra difficoltà dell’ecosistema giornalistico: ripensarsi completamente in funzione del mantenimento della propria missione e dell’adattamento al mondo che cambia. Così, si arriva finalmente a una definizione positiva di slow journalism, che non ha nulla a che vedere con il digital detox o la rinuncia alla tecnologia (come qualcuno potrebbe pensare) e che non è strettamente legata alla velocità ma che, piuttosto, riprende la definizione del cibo di slow food: “buono, pulito, giusto”.
I contenuti sono dei veri e propri asset per le imprese di slow journalism. Il che significa che, nei limiti del possibile, si lavora a piani editoriali che “non scadono”. Ci saranno contenuti più prettamente immediati, legati a un preciso momento storico, e altri, invece, che potranno essere fruiti anche dopo molto tempo. In generale, anche i contenuti immediati sono pensati per costituire un elemento di valore aggiunto e per essere riutilizzati. Ecco allora che il “buono, pulito e giusto” diventa vero anche nel giornalismo. Buono perché è di valore. Pulito perché è trasparente, verificabile, indipendente. Giusto, perché non pretende di essere portatore di un verbo, non si trincera dietro l’auctoritas ma è onesto intellettualmente, si corregge, si sottopone a procedure di verifica. Giusto perché le persone sono pagate bene per il lavoro che fanno.
Naturalmente slow non significa che un giornalista non possa o non debba occuparsi delle notizie in emergenza o delle breaking news: è evidente che, nel mondo in cui viviamo, ci sia bisogno sia di chi è in grado di fare sia reportage dal vivo che approfondimento. Ma le breaking news si sono sempre più rapidamente trasformate in commodity, in contenuti, cioè, senza un brand di riferimento, che vagano liberi in rete.
Lo Slow Journalism esiste già. E funziona. Fra gli esempi esteri che sono a un passo dall’essere sostenibili o che hanno già una struttura che li colloca di fatto nel novero di coloro che hanno trovato la loro via, ci sono per esempio:
– Zetland (Danimarca). Di base digitale, chiama i suoi abbonati “membri”. La produzione digitale è contenuta (2 o 3 pezzi al giorno). Poi alcuni pezzi diventano anche libri di carta o eventi dal vivo. La homepage del sito è, di fatto, una vetrina di marketing. A Zetland combinano il lavoro giornalistico, pianificato con 2 settimane d’anticipo, con la gestione della community, il concetto di membership, lo sviluppo di funzionalità interne con uno staff di programmazione e sviluppo proprio. Nuovi rilasci sono effettuati anche grazie all’ascolto dei membri, come ad esempio il podcast degli articoli, fortemente richiesto dalla base degli abbonati. In redazione viene utilizzato consapevolmente il termine slow journalism.
– Delayed Gratification (UK). Rivista di carta, trimestrale, contiene grande giornalismo su fatti terminati nel trimestre precedente a quello dell’uscita. Il design è uno degli elementi connotanti di questo pilastro dello slow journalism. Il digitale non è negato ma usato come elemento di “conversione”, ovvero come vetrina, come strumento di marketing. Rivendica lo slogan Join the Slow Journalism revolution.
– De Correspondent (Paesi Bassi) e l’epigono in lingua inglese The Correspondent. Una realtà protagonista di due crowdfunding impressionanti con un’idea filosofica alla base molto solida e la capacità di mettere a punto, nell’ecosistema giornalistico, campagne e strategie comunicative che attingono a molti mondi differenti, imparando, prima di tutto, a raccontare la propria idea di giornalismo. A De Correspondent non usano per scelta il termine slow, ma tutto l’approccio è coerente con questa filosofia. In inglese non hanno ancora pubblicato nulla: inizieranno le pubblicazioni il 30 settembre 2019, dopo una lunga preparazione e una lunga fase di ascolto delle persone rispetto ai loro bisogni e desideri. Hanno un modello di business che prevede il paga-quanto-puoi. Rivendica lo slogan Unbreaking the new.
In Italia, il primo progetto di slow journalism che si rivolge a un pubblico pagante è Slow News, con il quale cerchiamo di applicare questa serie di principi “rivoluzionari”. Abbiamo iniziato a studiare anche da piccoli imprenditori e, soprattutto, abbiamo cercato nel mondo chi stava facendo qualcosa di simile. Abbiamo conosciuto Peter Laufer, autore di Slow News: A Manifesto for the Critical News Consumer e molte redazioni: stiamo raccontando questa rete slow in un film-documentario il cui teaser è visibile qui. Anche noi passeremo a breve al modello paga-quanto-puoi. In un certo senso, fare slow journalism è una forma di attivismo. Non abbiamo garanzie che l’approccio slow funzioni e sappiamo che andrà declinato in maniere diverse, perché l’idea di trovare un unico modello che vada bene per tutti non è più praticabile. Quel che è certo, però, è che il modello attuale, generalizzando, non sia più sostenibile e che sia arrivato il momento di lavorare seriamente per sostituirlo con altro. Quell’altro potrebbe essere l’approccio dello slow journalism. Che non è la panacea di tutti i mali, ma risolve senza dubbio alcuni problemi.
Alberto Puliafito è autore, insieme a Daniele Nalbone, di Slow News. Chi ha ucciso il giornalismo?, edito da Fandango Libri
Tags:crowdfunding, libri, membership, modelli di business, New Yorker, Peter Laufer, Slow Journalism



















