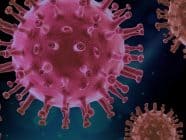Ore infinite davanti allo schermo del computer con solo una breve pausa per il pranzo in cucina a pochi metri di distanza, tutto per poi tornare al lavoro fino al tramonto, per poi abbandonarsi sul letto, solo per ripetere la medesima routine, di giorno in giorno, con nient’altro se non una breve passeggiata all’aperto per cercare di mettere a proprio agio la mente costantemente “on”.
Un senso continuo di terrore mentre guardi i dati sui contagi salire in tutto il mondo, con nient’altro a cui pensare o di cui parlare con le facce delle persone connesse attraverso lo schermo del computer. Forse sei del tutto solo, o forse hai un partner con cui confortarti, o dei bambini che strisciano sulle tue ginocchia.
Dopo più di un anno di vita con una pandemia globale che chiude il mondo, questi sono tutti scenari familiari per tutte e tutti. E mentre i lockdown stanno iniziando a essere sollevati in buona parte del mondo, le preoccupazioni iniziano a crescere sulla possibilità di un’imminente crisi di salute mentale provocata da un anno di isolamento di massa, incertezza e terrore senza fine.
I giornalisti esposti a sofferenza a lungo termine – molti dei quali già lottano con i loro traumi dovuti a un’industria conosciuta in particolare per i suoi ambienti ostili e ad altra pressione – sono particolarmente vulnerabili agli effetti di ciò che la psicologa Esther Perel descrive come un “disastro psicosociale”. Perel si riferisce al trauma collettivo derivante dalla preoccupazione, dalla solitudine e dal dolore creati dalla stranezza della vita e dal lavoro confinato in un solo luogo.
Perel ha parlato di questi problemi in un recente podcast, “Breaking news has broken us”, in cui la psicologa ha analizzato come la pandemia sia stata per i giornalisti un periodo particolarmente duro, in cui è stato molto difficile trovare tregua o sostegno. “Le redazioni sono in uno stato di dolore e hanno subito perdite enormi nell’ultimo anno. È uno stato di trauma collettivo, e i giornalisti sono esausti”, ha detto Perel: “sono personaggi attivi della stessa storia che stanno raccontando”.
La bolla della pandemia
Perel non è però l’unica a evidenziare questo problema. Un numero crescente di giornalisti ha lamentato burnout e gravi problemi di salute mentale e si sta battendo per un maggiore sostegno sul posto di lavoro. Tra questi c’è John Crowley, un giornalista con oltre 20 anni di carriera. All’inizio di quest’anno, Crowly ha co-firmato il report “Journalism in the time of Covid”, in cui ha esaminato le esperienze di 130 intervistati da tutto il mondo. Tutte le persone sentire per il report hanno riferito di essersi sentite sotto pressione o in burnout.
“Molti dei giornalisti e delle giornaliste che ho pensato di sentire erano in una ‘bolla pandemica’. Molti sembravano non riuscire a fuggire dalle cattive notizie incessanti che avevano il compito di coprire”, dice Crowley all’EJO. “Anche i giornalisti parlavano con le persone, tenendo fede al loro ruolo, ma nessuno si stava chiedendo come stessero davvero”, ha aggiunto. Questo tema è ricorrente nelle interviste che l’EJO ha condotto con giornalisti e giornaliste alle prese con le conseguenze psicologiche della pandemia.
“I giornalisti hanno lavorato in modo estremamente duro nell’ultimo anno, a vari livelli di pericolo personale. Tutti però abbiamo avuto costantemente questa pandemia sulle nostre teste, e senza possibilità di fuga”, ha dichiarato una giornalista che ha coperto la pandemia dall’Asia.
“Guardare il virus viaggiare a ondate in tutto il mondo mi ha ricordato il guardare una sorta di incidente al rallentatore. Dall’Asia, ho potuto vedere l’inevitabilità del suo arrivo in Europa e negli Stati Uniti, ma i paesi occidentali non stavano chiudendo i confini e non controllavano le temperature dei cittadini. Un amico nel Regno Unito mi ha mandato mascherine, e ho detto alla mia famiglia di comprare salviette disinfettanti per prepararsi. Il mio amico si era preparato, ma la maggior parte delle persone non aveva idea di quello che stava per arrivare”, dice la giornalista.
Questi problemi erano resi ancora più preoccupanti dagli atteggiamenti dei colleghi sul posto di lavoro che hanno fatto sentire la giornalista non sostenuta, sottovalutata e a volte in pericolo. L’intervistata ritiene che la famosa e perdurante cultura machista del settore sia in parte da incolpare per questa difficile esperienza.
“Le risorse umane hanno inviato una serie di email con suggerimenti. Uno di questi era quello di spegnere tutto ed evitare le notizie, il che è impossibile per una giornalista che lavora sulla pandemia. Nella nostra redazione perdura un’idea per la quale dovremmo correre verso le storie emozionanti e affrontarne le conseguenze solo più tardi, se non ignorarle del tutto. Non importa quanto queste possano essere traumatiche”, aggiunge la giornalista, secondo la quale l’impatto estremamente stressante della pandemia sul suo lavoro è stato in buona parte minimizzato.
“I miei editor hanno sistematicamente rifiutato la possibilità che osservare costantemente le notizie sul virus e sui suoi vari effetti avrebbe potuto avere un impatto su di me. Mi è stato risposto che i vaccini stavano arrivando e che c’erano buone notizie là fuori, quindi non tutto era così deprimente”, aggiunge la giornalista.
La giornalista, inoltre, attribuisce gran parte di questa leggerezza alla cultura maschile dominante nella sua redazione, lamentandosi anche della sottovalutazione del virus, considerato in ufficio come una questione banale. “In realtà non penso che i miei colleghi maschi lavino le mani molto spesso, il che mi ha fatto desiderare di evitare l’ufficio”, ha aggiunto.
La tempesta perfetta
John Crowley è d’accordo sul fatto che la cultura machista e antiquata del giornalismo abbia contribuito alla crisi di salute mentale che i giornalisti provati da da un anno e oltre di copertura sulla COVID-19 devono ora affrontare. Questo elemento va aggiunto alla lunga lista di problemi strutturali e sociali che interessano il settore.
“I giornalisti negli ultimi dieci anni si sono trovati nel bel mezzo di una tempesta perfetta”, dice Crowley. “Fallimento dei modelli di business, insicurezza sul lavoro, traumi, disinformazione, molestie online e la pressione di essere costantemente ‘on’ hanno preso il sopravvento. Questo era certamente vero già ben prima che arrivasse la pandemia. Questi sono problemi sistemici del settore che ora possono solo diventare più acuti. Qualcosa dovrà cambiare”, aggiunge Crowley.
L’approccio miope dei media nell’affrontare i sintomi dello stress e del trauma non aiuta certamente a migliorare la situazione, aggiunge Crowley, in un momento storico in cui le nazioni in tutto il mondo seppelliscono le loro teste sotto la sabbia quando si tratta di affrontare il tema di una possibile crisi di salute mentale imminente.
“Le nazioni tendono a loro volta ad avere un atteggiamento incredibilmente macho”, aggiunge il giornalista, “questo perché molte sono ancora governate da uomini bianchi, di mezza età che hanno imparato il mestiere facendo i duri. Questo probabilmente ha significato essere aggressivi verbalmente, essere trattati male e dover lavorare in modo estremamente duro. Per queste ragioni, alcuni di questi governanti potrebbero pensare che se si sono formati loro in quel modo, allora i nuovi arrivati dovrebbero fare lo stesso perché questo modus operandi li renderà più duri. Io direi loro di dare un’occhiata fuori. Il mondo sta cambiando”, aggiunge Crowley.
Secondo Crowley, le generazioni più giovani sono più abili nel conoscere e affrontare la consapevolezza della salute mentale, il che significa che sono molto meno propense a sostenere il trattamento cui la sua generazione è stata abituata. “C’è una nuova presa di coscienza in arrivo per chi pensa che si possa continuare ad infinitum in questo modo. Per far sì che il cambiamento avvenga, dobbiamo però passare dal parlarne all’assicurarci che le nostre voci vengano ascoltate. Se questo richiederà alzare la voce, così sia”, aggiunge Crowley.
Una maratona senza traguardo
Come Crowley ha così eloquentemente descritto, lo stress generato dalla pandemia è solo la punta dell’iceberg del problema, dato che molti giornalisti e giornaliste stanno già affrontando gli effetti delle precedenti esperienze di copertura di storie traumatiche.
Tra questi c’è Jarrod Watt, un reporter australiano di lungo corso che ora lavora come Specialist Digital Editor al South China Morning Post a Hong Kong. Watt ha coperto la pandemia mentre si occupava anche delle proteste e delle violenze dello scorso anno a Hong Kong, per non parlare dei dei sintomi da disturbo da stress post-traumatico (PTSD) causati dal lavoro precedente sugli incendi estivi in Australia per l’Australian Broadcast Corporation.
“Ho trascorso più di un decennio a coprire, produrre e coordinare la fornitura di notizie sugli incendi e anni interi alle prese con i sintomi da PTSD causati dall’essere costantemente vigili per quattro mesi ogni estate, scansionando costantemente mappe e bollettini meteorologici per possibili minacce alle città e ai villaggi”, dice Watt all’EJO.
“Questo sprint annuale è stato sostituito, con la pandemia, da una maratona senza traguardo chiaro, e una nuova sfida caratterizzata dallo scorrere ossessivamente i feed di notizie ogni giorno e dalla minaccia della disinformazione sui social media, il tutto mentre guardavo come le cose si stessero mettendo molto male nel paese d’origine della mia partner, o vedevo i miei amici e la mia famiglia a Melbourne finire in un lockdown molto duro”, aggiunge Watt.
Con questa consapevolezza di come il lavoro giornalistico sugli eventi difficili possa causare danni psicologici, per il giornalista è stato scoraggiante vedere gli effetti delle proteste dell’anno scorso a Hong Kong sui giornalisti, proteste che includevano violenti scontri tra la polizia locale e i manifestanti.
“La PTSD tra i giornalisti non è normalmente considerata a meno che tu non sia stato in guerra o coinvolto in uno scontro a fuoco. Eppure esiste”, sostiene il giornalista. “Ho visto tanti grandi giovani giornalisti a Hong Kong crollare durante il 2019 al punto da lasciare questo lavoro”, aggiunge Watt. Chi è rimasto in servizio durante la pandemia, come Watt, ora deve anche far fronte all’eredità degli eventi dello scorso anno e al livello scioccante di brutalità visto nelle strade di Hong Kong che, fino ad allora, erano considerate tra le più sicure al mondo.
Una giovane reporter di Hong Kong, contattata dall’EJO, ad esempio, soffre ancora per le conseguenze di ciò che lei descrive come un periodo di lutto prolungato iniziato dopo aver coperto le proteste per conto di una “testata online alternativa” che non le ha fornito alcuna formazione sul lavoro in ambienti ostili, né qualsiasi attrezzatura protettiva. Come giornalista bilingue, si è ritrovata sobbarcata da troppo lavoro e troppo poco sostegno, una serie di circostanze purtroppo molto familiari ai giornalisti di Hong Kong.
“Parte del problema è stata che il mio editore fosse un piccolo sito, e che il capo non si aspettava inizialmente che io coprissi le proteste così estensivamente. Inoltre, c’era questo presupposto per il quale, se sei giovane e vuoi lavorare, farai di tutto per essere presente sul campo a causa dell’esperienza che puoi ottenere. Ma il risultato dell’essere l’unica persona in ufficio che parlava cantonese, unito al peso del lavoro di reporting è stato che stavo solo andando in burnout, una cosa di cui non penso i miei capi in quel momento fossero particolarmente consapevoli”, ha aggiunto la giornalista.
Durante i disordini, questa giornalista è diventata sempre più esausta a causa del carico di lavoro e dello stress al punto da svenire sui mezzi pubblici. Da allora, la giornalista si è trasferita in un’organizzazione più grande, dove ora copre le notizie internazionali. Ma i suoi ricordi dei disordini dello scorso anno ancora la perseguitano, come è per molti altri in città: “al lavoro, copro notizie internazionali in questi giorni, ma ogni tanto, mi sono ritrovata a piangere improvvisamente alla mia scrivania ogni volta che dovevo ascoltare qualcosa e c’era anche solo il suono dei gas lacrimogeni in sottofondo”.
Enough is enough
La domanda da porsi ora è: quali misure possono essere prese per affrontare il trauma nelle redazioni e per creare un ambiente in cui possa prosperare una diversità di talenti? Il podcast di Perel suggerisce di non considerare il trauma come un’esperienza solo individuale, al fine di gestire e rafforzare piuttosto le relazioni di sostegno dentro e fuori dal luogo di lavoro.
“Si sente molto parlare di meditazione e di mindfulness, quando in realtà ciò di cui abbiamo bisogno durante un periodo di trauma collettivo è attingere alle risorse di altre persone”, ha detto Perel. In effetti, tutti i giornalisti intervistati dall’EJO hanno sottolineato l’importanza di chiedere aiuto ad amici, familiari e partner. Per Crowley, questo onere dovrebbe spettare ai responsabili delle redazioni, che dovrebbero prendersi più cura dei propri dipendenti e garantire che il loro benessere abbia la priorità.
“I leader e i management delle redazioni devono conoscere questo problema. Certo, ci sono lodevoli eccezioni in cui le organizzazioni giornalistiche più illuminate pensano davvero al benessere del loro personale. Ma nel complesso, quello che vedo sono teste che vengono sotterrate nella sabbia. Prendersi cura del proprio personale è, ovviamente, la cosa giusta da fare, ma se siamo così pronti a predicare al pubblico sulla salute mentale, dobbiamo anche attenerci a uno standard più elevato noi per primi”, dice Crowley.
“Quando è troppo è troppo. È tempo che il settore faccia il punto e ascolti la sua risorsa più preziosa: le persone. Si può giustamente accusare il giornalismo di non essersi adattato a Internet e di aver cambiato le abitudini dei consumatori negli ultimi due decenni. Non facciamo, però, lo stesso errore con la nostra cultura del lavoro”, conclude Crowley.
Articolo tradotto dall’originale inglese.
Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle degli autori e degli intervistati e non rispecchiano necessariamente quelle di tutto l’EJO.
Tags:COVID-19, disturbo da stress post-traumatico, Hong Kong, pandemia, salute, salute mentale, trauma