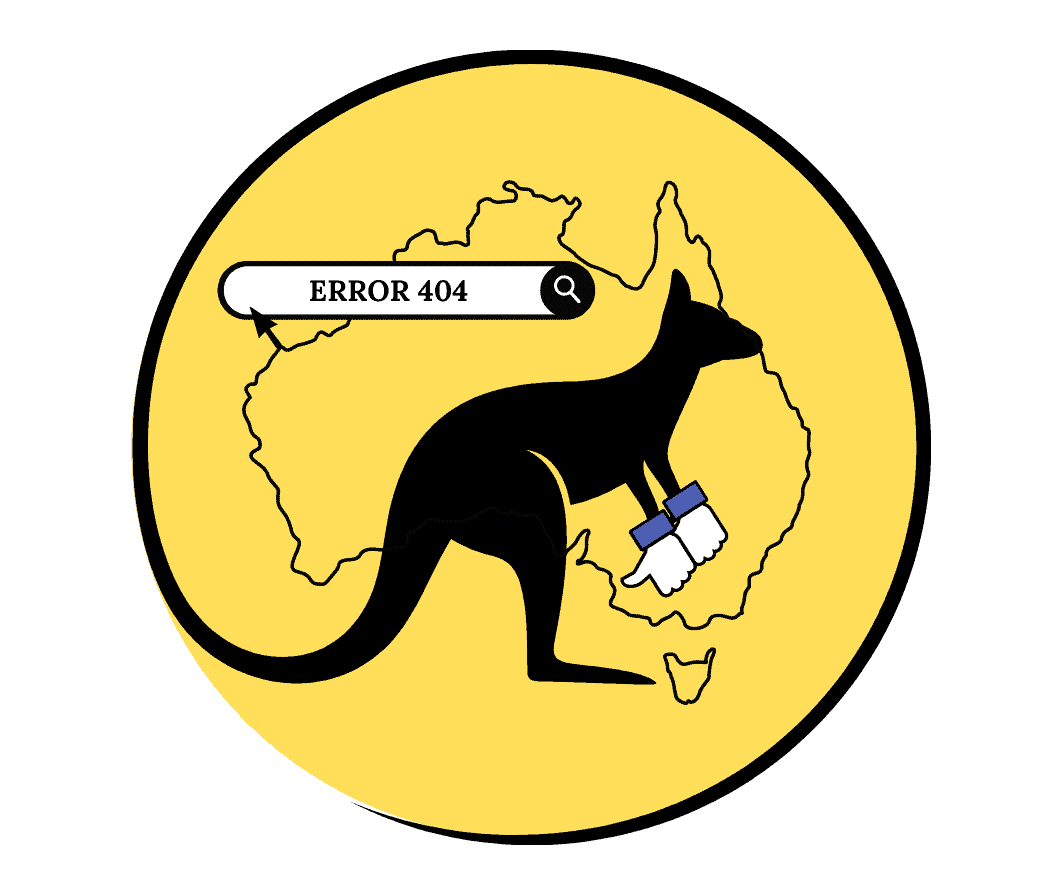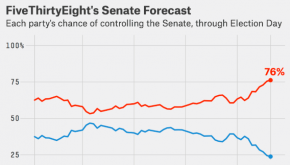Questa è una puntata di “Ellissi”, la newsletter settimanale di Valerio Bassan, dedicata al futuro dei media e alle nuove economie del digitale. È possibile iscriversi qui.
Ogni tanto, in Australia, il futuro arriva in anticipo. Succede l’ultimo giorno dell’anno, per esempio: mentre i fuochi d’artificio illuminano le guglie dell’Opera House di Sidney, da noi è ancora l’ora della merenda.
In questi giorni nella terra down under sta succedendo qualcosa di simile: stiamo assistendo alle conseguenze di un ipotetico avvenire, ricco di luci abbaglianti ed esplosioni artificiali. Un avvenire in cui, tuttavia, ben pochi stapperanno il prosecco.
Andiamo con ordine. Che succede in Australia?
Ne avrai già sentito parlare: ieri il parlamento di Canberra ha approvato ufficialmente il News Media Bargaining Code. La legge, figlia di un’indagine dell’antitrust australiano, costringe le grandi piattaforme digitali a stringere accordi economici con i gruppi editoriali per continuare a veicolare i contenuti giornalistici.
In soldoni, il decreto è stato creato per colpire Google e Facebook, i due enormi marketplace dell’attenzione digitale che da un decennio si spartiscono una fetta maggioritaria della pubblicità online. Se ne è parlato tantissimo. È la prima volta, infatti, che un governo cerca di imporre un vincolo così restrittivo ai colossi del web, nel giornalismo e non solo.
Fin dalla sua prima diffusione, avvenuta una settimana fa, il testo della legge mostrava diverse lacune: non definiva con chiarezza chi dovesse essere remunerato, per esempio, né quanto, o per quanto tempo. L’unica cosa davvero certa erano le multe milionarie per i trasgressori. La questione si è fatta subito interessante: la discussione parlamentare della legge ha infatti scatenato reazioni opposte.
Google ha subito stretto accordi con alcuni dei principali gruppi editoriali del paese — da Guardian Australia a News Corp., la media company di Rupert Murdoch, tra i promotori-ombra del Bargaining Code. Facebook invece ha messo in atto una dura resistenza, bloccando la pubblicazione di link provenienti dalle testate giornalistiche, e impedendo agli utenti australiani di accedere a qualsiasi fonte d’informazione sulla piattaforma.
Così, dal giorno alla notte, Facebook Australia è diventato uno sterminato news desert. Per capire meglio l’entità della posta in gioco: nel 2020 il 52% degli australiani dichiarava di utilizzare i social network come fonte primaria di accesso alle notizie.
Chi ha preso la decisione giusta?
Google non aveva molta scelta: il contenuto giornalistico è un asset fondamentale del suo servizio, e gioca un ruolo chiave nel determinare la rilevanza dei risultati di ricerca. In più, molti degli accordi sottoscritti rientrano in una strategia legata al Google News Showcase, il nuovo prodotto di Google dedicato all’aggregazione di notizie lanciato in Australia all’inizio di febbraio.
Facebook, invece, ha tenuto fede al suo mantra “we are not a media company”, che ripete religiosamente da anni (penso sia appeso in tutti gli uffici di Menlo Park). E ha avuto ragione: con le cattive, la piattaforma ha convinto il governo australiano ad apportare sostanziali cambiamenti alla legge prima della sua approvazione finale.
Oggi il Bargaining Code non impone più alle piattaforme digitali di pagare per tutti i contenuti giornalistici, ma lascia loro libertà di scegliere i partner con cui stringere accordi. Inoltre, chiunque dimostrerà di avere sottoscritto autonomamente “un numero sufficiente di accordi” con le testate non rischierà più alcuna sanzione.
Così, ora, anche Facebook negozierà con gli editori — ma senza fretta né pressioni, e soprattutto con la possibilità di dettare le proprie condizioni. A breve, ha annunciato il social network, la notizie torneranno a circolare liberamente nei feed degli australiani.
Chi stappa il prosecco?
Tutti hanno ottenuto qualcosina da questo braccio di ferro — gli editori sono riusciti a far sentire la propria voce (e, almeno i grandi gruppi, a guadagnarci qualcosa), mentre le piattaforme hanno ribadito la loro centralità e la loro forza negoziale.
Eppure io credo che l’intera situazione sia solamente una vittoria dell’ipocrisia.Ogni editore è libero di rimuovere i propri contenuti su Google. Ci vogliono pochi minuti, basta aggiungere una riga di codice al sito. Allo stesso modo, ogni giornale può cancellare i propri profili ufficiali da Facebook e Instagram, in qualsiasi momento. C’è un motivo se tutto questo non accade: le piattaforme inviano volumi esorbitanti di traffico alle testate.
Di fatto, promuovendone – gratuitamente, ovvio – i contenuti.Senza questo supporto dalle piattaforme, tutti i giornali perderebbero non solo entrate economiche, ma anche una buona fetta del proprio pubblico. Alcuni rischierebbero di finire nel dimenticatoio. La verità è questa: c’era un tempo in cui i giornali detenevano il monopolio dall’attenzione.
Se oggi le cose sono cambiate, la colpa è soprattutto loro: è la conseguenza di tante scelte sbagliate, di contenuti sempre meno rilevanti, e di formati sempre meno adatti a veicolarli. Se semini sabbia, insomma, raccogli deserto. In fondo, non tocca a Facebook e Google riparare i modelli di business rotti delle testate.
Non c’era una soluzione migliore?
Questa, per esempio: tassare Facebook e Google in proporzione ai loro profitti, e fare in modo che paghino la giusta percentuale di contributi. Con questi soldi, poi, si potrebbero fare due cose:
– Incentivare la nascita di progetti di modernizzazione nelle aziende giornalistiche, aiutandole a ottimizzare i propri modelli di business.
– Dare una mano a chi ha poco potere negoziale: le redazioni piccole, i giornali locali, le testate no profit. E in particolare aiutare i freelance, la spina dorsale del giornalismo presente e futuro.
Perché mi viene il sospetto che alla fine in queste prove di forza non ci siano vincitori, e che gli sconfitti siano sempre gli stessi: i lettori.
Tags:Australia, contributi editoria, Facebook, Google, Link